Day 4
Il quarto giorno inizia presto con la proiezione alle 10 di Disco Limbo, dei due registi Fredo Landaveri e Mariano Toledo. Spasmi di malickiane voci fuoricampo, facili lirismi lynchani e sommesse atmosfere hip-hop vengono frullate al servizio di un’ora e venti fuori controllo (almeno sulla carta), in cui il giovane protagonista David, recatosi ad una festa assurda e spericolata, incontra il misterioso Lucio e intraprende con l’occasione un trip lisergico che passa direttamente attraverso la misteriosa presenza dell’amica italiana Maria e attraverso una scarpinata in territori desertici presa a piene mani da Gerry di Van Sant. Si capisce, insomma, che i due registi siano cinefili, e si capisce che vogliano sperimentare con il montaggio. Ma pure sorvolando sulla velleità delle spiritosaggini disco-techno e ai jump-cut a ritmo di musica discotecara, si rimane infastiditi dall’ostinazione tutta fumosa di una mise en scène gratuita e poco sagace e dal presto esaurirsi dello stupore (dopo venti minuti, siamo già assuefatti a tutto), tanto che nemmeno gli scambi identitari alla Bunuel possono far nulla per salvare le sorti di un film maldestro. Si premia il coraggio.
Voto: **1/2
Disco limbo (2016): locandina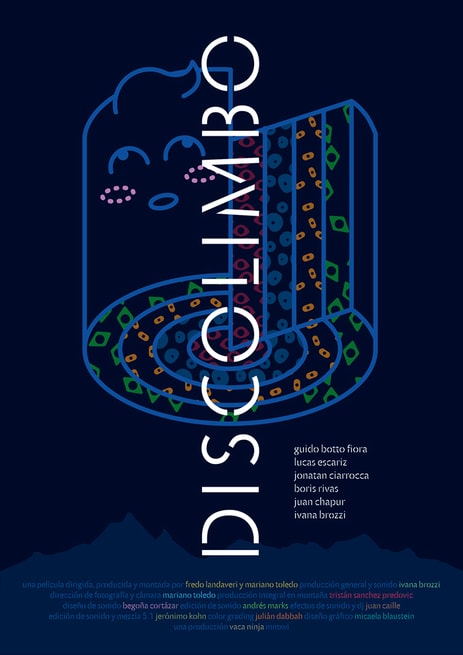
Abbastanza sfortunata è anche la visione delle 12: Bruder der Nacht di Patric Chiha prometteva un mix fra Cinema-Verité e un formato filmico fassbinderiano. In realtà di Fassbinder sembra che si sia visto solo Querelle de Brest, citato pedissequamente per l’intero minutaggio (pretestuosi i continui accostamenti blu-arancio della fotografia); per il resto del grande regista tedesco non c’è niente, né la caustica ironia che lo attraversava, né la cinica fissità che lo caratterizzava. D’altronde questo Brothers of the Night è un documentario, ma non solo sembra voler indicare spesso di cercare l’empatia fra personaggi ripresi e spettatore (fallendo), chiede anche attenzione nei confronti di situazioni che si ripetono stancamente e senza alcun senso del ritmo visivo. Tra enfatiche boccate di sigaretta e ubriacature moleste, i giovani sbandati ripresi (quasi tutti eterosessuali che si prestano alla prostituzione omosessuale) vengono avvolti di un superficiale e ovvio maledettismo, e per quanto un paio di sequenze siano azzeccate (il finale danzante), si capisce che fra le righe sta malcelata la ricerca di un facile pietismo.
Voto: **1/2
Brothers of the Night (2016): locandina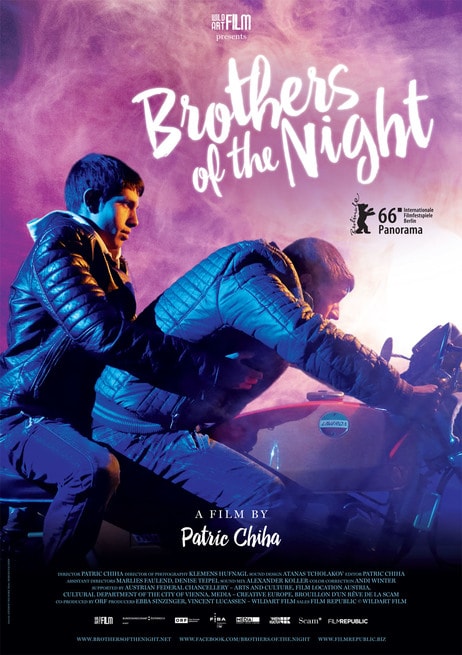
Superato il pranzo, alle 16 si è di nuovo in sala per la seconda parte della retrospettiva su Gabriel Abrantes. Questa volta vengono proiettati alcuni dei suoi lavori iniziali, che rivelano un po’ le radici dell’Autore portoghese.
In Anarchist King (voto: **) l’immaturità entusiastica del regista non riesce a produrre nulla di interessante; in compenso, si affacciano timidi riferimenti alle neoavanguardie statunitensi degli anni ’60, con suggestioni in 16 mm già viste e risapute. Non colpisce nemmeno il lavoro sul linguaggio e sulle didascalie: un giochetto inerte. Quanto c’è qui, era per giunta già stato scoperto (in ritardo anche in questo caso) dai primissimi corti scolastici di David Cronenberg.
In Olympia I & II (voto: **) Abrantes ci mette la faccia, rivisitando due volte il soggetto di Manet prima stando dietro la macchina da presa mentre una donna lo insulta, e poi interpretando lui stesso Olympia. Dice Abrantes che cercando di distruggere quanto più noi amiamo, riusciamo a metterci in discussione. Ma il suo modo di distruggere questa particolare iconografia, per lui tanto significativa, ha pochissimo di personale, e prende troppo in prestito dalla factory warholiana (l’ossessione per i corpi scolpiti dalessandrini, il voyeurismo, i marchi occidentali come elementi inquinanti dell’immagine, la cinepresa morrisseyana in continuo movimento). Abrantes nel 2008 pensa forse di scoprire una sua via personale che è in realtà acqua calda in ritardo di 50 anni.
In Visionary Iraq (voto: **1/2) è ancora ingombrante il peso dell'influenza del cinema statunitense anti-hollywoodiano; in compenso, la fotografia è visionaria proprio come promette il titolo, e la duplicazione della coppia protagonista in tre coppie diverse (interpretata da Abrantes e Benjamin Crotty) ha un ché di ammaliante. Delirante (in senso buono) il finale. Ma l’ironia è ancora stagnante.
In Too Many Daddies, Mommies and Babies (voto: **1/2) finalmente Abrantes innesta un elemento originale: trasforma la Neoavanguardia in un improbabile melodramma gay-friendly a favore dell’utero in prestito per concedere un figlio alla coppia gay protagonista. Il film è talmente sopra le righe che non si riesce a prendere sul serio (né vuole essere preso come tale), ma il supposto fascino del 16 mm ad ogni costo comincia a stare stretto alle ambizioni del giovane regista portoghese.
Finalmente, con Palàcios de Pena (voto: ***1/2) Abrantes scopre il collage. Cambiando registro ogni cinque minuti nell’arco di un’ora, il regista portoghese trova una formula affascinante per raccontare il rapporto oscuro e altalenante di due sorelle che alla morte della nonna devono decidere a chi di loro due andrà un patrimonio legalmente indivisibile. Il film è davvero un viaggio fantasmagorico, che parte da Tarkovskij, passa attraverso visioni giovanilistiche di certo cinema più contemporaneo, per poi deragliare in visioni pasoliniane e bunueliane. Sorprendente e di matrice shakespeariana (Re Lear su tutti), Palàcios de Pena permette ad Abrantes di aggiudicarsi il titolo di importante esponente del cinema portoghese contemporaneo, a fianco di Miguel Gomes, benché sia decisamente meno consapevole delle possibilità dell’umorismo rispetto a quest'ultimo. Siccome quanto faceva prima era già visto, Abrantes sembra capire che è rimischiando le ceneri di quanto già esiste che può nascere la novità.
Palácios de Pena (2011): locandina
Alle 18,30 (in realtà un poco in ritardo) partono i primi 8 cortometraggi in concorso nella sezione Queer Short.
Division Movement to Vungtau di Crotty e Dezoutex è un film alieno fatto di velocissimi flash assurdi e improbabili. Con spunti che paiono pescati dal Bananas alleniano, Crotty prende del materiale d’archivio e lo trasforma in una satira anticonvenzionale, in cui il mondo militare (già analizzato in maniera originale e improbabile nel bellissimo Fort Buchanan) non sa vedere il delirio che lo circonda. 4 minuti di immagine che si ribella a se stessa.
Voto: ***1/2

A fronte di tanta originalità, si torna purtroppo coi piedi per terra con l’ordinaria amministrazione di A Wig and a Prayer, che racconta della drag queen Peaches Christ e dei suoi spettacoli itineranti in grande anticipo sui tempi. Formalmente non c’è nulla, ma in un atmosfera a cavallo fra John Waters e il Rocky Horror scappa qualche sorriso.
Voto: **1/2
A Wig and a Prayer: The Peaches Christ Story (2016): locandina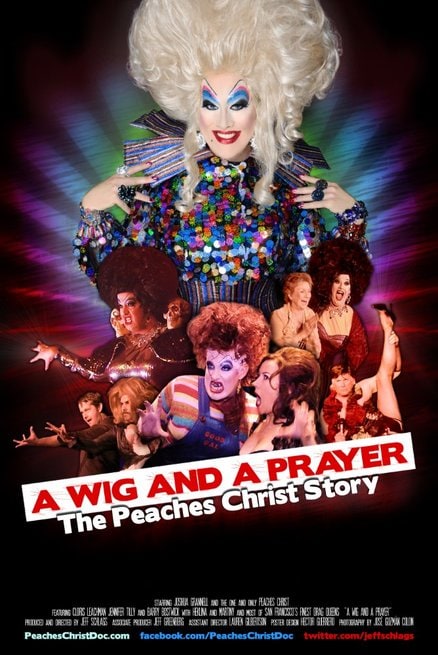
Filip è un insignificante filmetto svedese che indaga la curiosità infantile e il rapporto fra fratelli. L’omosessualità attraverso uno sguardo puro e innocente (con annesso bacio con sole in stile Vie d’Adèle): neanche un bandolo di originalità.
Voto: **
Filip (2015): scena
Les Iles di Yann Gonzales è il capolavoro di questa porzione di cortometraggi. Gonzales si aggiudica il titolo di Lynch queer, in quanto non solo possiede un tratto e uno stile riconoscibili, ma bilancia la sua personale visione delle cose (labile il confine fra sogno e realtà, fra verità e spettacolo) e i tributi nei confronti della visionarietà dei grandi del passato (Lynch, appunto, ma anche Bunuel). Un corto che avrebbe potuto intitolarsi Silencio, in cui l’osceno è trasfigurato e l’oscurità è spinta propulsiva verso l’amore libero e la vita.
Voto: ***1/2
Islands (2017): locandina
Beautiful Figure, dall’Ungheria, è il delicato tratteggio di un innamoramento. Si capisce fin dall’inizio che non promette nulla di davvero particolare, ma il film ha le palle per concludersi pessimisticamente.
Voto: **1/2
Beautiful Figures (2016): locandina
Secret Santa Sex Party è un filmetto di propaganda, tematicamente coraggioso, che racconta dei raduni orgiastici dei gay anziani a New York, esclusi dai pub gay per più giovani e in grado di consolarsi da solo fra loro. Per fortuna c’è dell’ironia.
Voto: **

Herculanum è lo spontaneo racconto di una storia d’amore gay che passa attraverso un incontro online, e finisce con una sottintesa promessa di amore eterno. Avrebbe potuto essere materiale per un lungo; in formato cortometraggio, non si arriva a provare affezione né simpatia per i due personaggi. Inoltre Jeremie Elkhain è irritantemente imbambolato.
Voto: **1/2
Herculanum (2016): Arthur Cahn
Infine, dall’Uruguay, con La piscina ci giungono agli occhi e alle orecchie indicazioni sconcertantemente banali su quanto sia giusto accettare le diversità e tutto il resto con pidocchiose scene sottomarine e ambientazioni alla Pelo Malo.
Voto: *1/2
The Swimming Pool (2015): scena
È finalmente la volta di O Ornitologo alle 20,30. Rispetto a O Fantasma, Rodrigues predilige atmosfere che dal reale passano al mistico. È il protagonista stesso a dire che non tutto può essere capito, infatti il film richiede allo spettatore un atto di fede, che fuoriesca dalla logica abitudinaria di ricezione spettatoriale e aderisca all’aspetto più istintivo e animale dell’essere umano. Infatti qualsiasi sovrastruttura civilizzata, in O Ornitologo, a poco a poco declina, a favore di spinte primarie che riconsegnano al loro legame indissolubile eros e thanatos. Senza scadere mai nell’horror, ma parlando di fatto di spiriti, fantasmi, tribù, rituali, violenza, sangue, religione e bigottismo, O Ornitologo propone una variante al modo più abusato di guardare all’oggi: la realtà non ha bisogno di tecnologia per essere frammentata, è già frammentaria in partenza a causa della moltitudine di punti di vista (i campi e controcampi soggettivi del protagonista e degli uccelli che lo fissano), ed è anche inconoscibile, misteriosa, pericolosamente bella. E intanto in due ore, davanti ai nostri occhi, viene disintegrato sempre con lo stesso impassibile, ma coerente, sguardo registico, qualsiasi schema e qualsiasi riferimento, benché per farlo si sia costretti ad affrontare un grottesco autocompiaciuto e un finale che permette allo spettatore la possibilità dell’interpretazione, quando invece la sfida era l’assoluta mancanza di appigli. Il Simbolismo al Cinema è ancora vivo, ma permette di orientarsi in un territorio che sembrava corragiosamente più spinoso.
Scena fondamentale, capolavoro di montaggio e narrazione, la non-morte per mano della valchiria poco tettuta. In quella scena Fernando (o Antonio?), per la nostra logica e il nostro modo di vedere, muore, ritorna in vita e muore nell’arco di pochi minuti, senza bisogno di sangue né di resurrezioni: vedere per credere.
Voto: ***1/2
O Ornitólogo (2016): locandina
Day 5
Alle 16, due brevi documentari. Per prima cosa, Les vies de Thérèse di Sébastien Lifshitz, un commovente resoconto di un’epoca e il ritratto toccante di una donna, scandito da una struttura documentaristica che alterna filmati di repertorio, foto e immagini del presente di Thérèse, quasi sul letto di morte. Le scelte formali di Lifshitz dimostrano tutto il suo talento di osservatore della realtà: vediamo scivolare via dalla vita Thérèse, con la sua persona, i suoi ricordi e tutto ciò che la rappresenta, tramite i continui close-up sul suo sguardo in stato di dormiveglia, che chiamano all’appello sentimenti come la tenerezza e soprattutto la comprensione. Non c’è l’intenzione di trasformare Thérèse in un’eroina, c’è l’intenzione di renderci partecipi di un punto di vista, che si chiude teneramente sulla sua voce e sui suoi ricordi dell’infanzia, in uno dei finali più strazianti visti al Queer in questi giorni.
Voto: ****
Les Vies de Thérèse (2016): locandina
Lives: Visible è meno aggraziato del documentario di Lifshitz, ma curioso e coerente nel momento in cui cerca di sviluppare il quadro di un mondo ormai passato tramite delle fotografie ritrovate nella casa di una coppia longeva di donne lesbiche decedute. Diviso in più capitoli che fanno riferimento a definizioni inerenti la fotografia (“cornice”, “mirino”, etc.), il film di Michelle Citron indaga l’iconografia e l’apparenza e il loro inevitabile legame con il desiderio: emblematica in tal senso la distinzione fra la posa delle pin-up, destinata al piacere degli uomini, e la posa delle donne omosessuali fotografate dalle loro amanti donne anch’esse. La cura del dettaglio e la precisione del discorso estetico fanno perdonare le svariate ingenuità del film, fra cui la scelta stucchevole di far leggere ad alcune donne del presente (anche lesbiche) le lettere di una delle due anziane decedute.
Voto: ***
Lives: Visible (2017): scena
Il terzo e ultimo appuntamento con i corti di Gabriel Abrantes getta una luce più chiara e ormai quasi definitiva sull’opera omnia del regista portoghese.
Se con Taprobana (voto: **1/2) resiste imperterrita l’emulazione dello sguardo pasoliniano e del suo grezzo esotismo, seppure con un livello di grottesco interessante in quanto sopra la media, con Ennui Ennui (voto: ***1/2), di un anno precedente, Abrantes realizza uno dei suoi lavori più centrati, in cui l’interesse anti-hollywoodiano non nega un certo approccio umoristico da screwball, anzi, fa finalmente notare quella ambita contraddizione che anche in altri lavori Abrantes anelava: la scelta di un formato commerciale per un film che condanni l’imperialismo del modello di cinema commerciale occidentale. Pur rimanendo il carattere ingenuamente reazionario del discorso di base, il film è genuinamente divertente, e fa svariati riferimenti letterari e cinematografici. La stoccata iniziale poi su Obama, e l’utilizzo del droide da distruzione, rendono di elevata taratura il sarcasmo di quest’opera.
Ennui Ennui (2013): locandina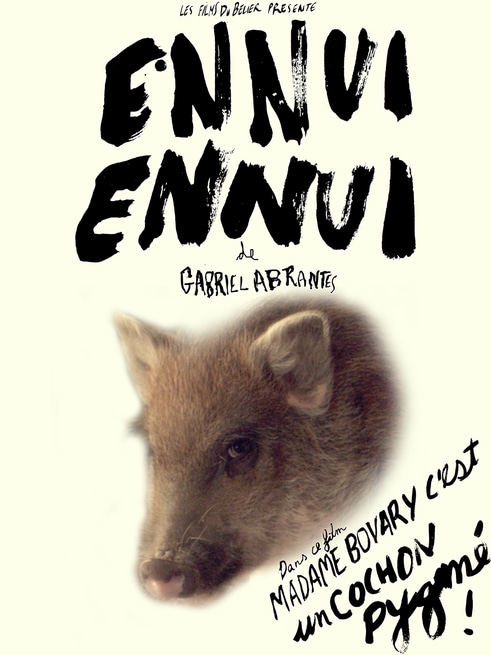
Liberdade (voto: **1/2), pur essendo un film molto sentito, lavora per ovvie contraddizioni. Realizzato insieme a Benjamin Crotty, è un attacco diretto nei confronti del colonialismo, che poi diventa metafora del cinema hollywoodiano in genere, e dell’assuefazione dell’immaginario collettivo a un modello prestabilito (ancora una volta, occidentale). Ambientato ad Angola, sfrutta l’idea di un collage concettuale-estetico per disorientare (si tratta dell’amore fra un ragazzo africano e una ragazza cinese, e degli ostacoli che l’impotenza di lui reca al loro rapporto) e indurre una riflessione che puzza un po’ di declamatorio. Però l’incipit è ammirabile e scatenato.
Fratelli (voto: ***) è l’unico film italiano di Abrantes, e si ricorda fra le altre cose anche per i costumi che sono gli originali dei Racconti di Canterbury di Pasolini, a questo punto esplicitamente citato. Il film è grezzo ma spiritoso, ed è una rilettura grottesca del modello pasoliniano sagace e interessante, per quanto si riduca quasi ad uno scherzetto non finito. Comunque un po’ fuori contesto l’incipit con la cupola del Pantheon.
Infine, A History of Mutual Respect (voto: **1/2), è ancora una volta una stoccata contro il colonialismo, e lo spiritoso racconto della contesa amorosa fra due giovani avventurieri, probabilmente drogati, su una ragazza “pulita”. Una volta trovato un candore selvaggio ma puro in una donna di una giungla brasiliana, uno di loro riuscirà ad ammaestrarla dopo una corsa nel bosco che può ricordare un po’ Borowczyk. Si tratta di un film con più idee che invenzioni, più intenzioni che raggiungimenti, acerbo, anche se rispetto al precedente Visionary Iraq segna una svolta importante.
Alle 20,30, si prosegue con il concorso di lungometraggi con Don’t Look At Me That Way, un film che mette d’accordo un po’ tutti, dai palati meno raffinati a quelli più pretenziosi. Asciutto, diretto, senza orpelli e senza trovate, se non nell’importante finale, il film di Useinma Borchu adotta una regia abbastanza impersonale per aderire agli ambigui ma molto veritieri personaggi, ricorrendo anche ad un’attenzione specifica per i corpi, gli sguardi e i movimenti. Quando si dice Cinema Queer, anche se in un esemplare ammaestrato e “per tutti”. Sfruttando poi la potenzialità sessuale di Useinma Borchu, vero e proprio corpo estraneo (di una donna di origine mongola in mezzo a biondi tedeschi), il film dirotta verso la conclusione che è impossibile dare una lettura precisa e autentica dei rapporti umani, in quanto questi sono troppo schiavi di passione e cinismo, oltre che fonte di desiderio di onnipotenza e controllo. E il film, per quanto parta evidentemente dall’invito all’introduzione del diverso nella propria vita (con un umorismo aguzzo non trascurabile), dribbla le conclusioni ovvie portandosi – con coraggiosa incoerenza – al punto da individuare proprio in un elemento estraneo una fonte di minaccia che sarebbe meglio eliminare. Una visione apparentemente controproducente, ma che in realtà rimanda al relativismo che governa negli eventi umani, e che può avere un riferimento nel Brecht citato dal padre di Iva alla folle Hedi.
Comunque per fare la qualità di tutto il film, basterebbe il montaggio finale, che disvela tutti i sottotesti impliciti di un evento violento, e rende quello stesso evento forse reale o forse solo immaginato.
Voto: ***1/2
Don't Look at Me That Way (2015): Uisenma Borchu, Catrina Stemmer
Dopo la visione di terzo e quarto episodio della web-serie su San Berillo di Maria Arena, indagine inerente la rivendicazione dei diritti delle prostitute transessuali nel disastrato quartiere catanese che dà il titolo al progetto, si è giunti a una delle esperienze del festival più attese da chi scrive: il nuovo lavoro del collettivo canatese canecapovolto.
Il primo film ad essere proiettato è stato Stereo_verso Infinito – Unfixed #26, vera e propria esperienza irripetibile, anche e soprattutto perché si tratta di un montaggio realizzato apposta per il festival, e che non sarà mai più reperibile in quanto cambierà, come cambia continuamente ogni 40 giorni già dal 2015. Un’esperienza dunque diretta, nel presente, pregna di paranoia e di paura. In effetti la visione del film è piuttosto angosciosa: tanti piccoli siparietti apparentemente scollegati di 30 secondi si susseguono come capitoli di una cornice più grande. I registi prestano particolare attenzione allo schema del film: ogni 30 secondi, vedremo il titolo del progetto, il numero del drone che avrebbe ripreso la scena che vedremo, e infine il titolo che può dare (o anche no) una chiave di lettura dei 30 secondi appena trascorsi. La decisione di affidare alla parola “drone” il riferimento per ogni filmato dà la sconcertante idea che gli eventi che osserviamo siano in realtà eventi spiati, osservati da punti di vista inesistenti, che deformano la realtà non solo nei suoni e nei colori, ma anche nella disposizione logica, spaziale e temporale, nel senso di un accadimento vero che preso in questa maniera così spezzata e improvvisa assume un significato del tutto differente da ciò che eventualmente aveva al momento della sua cattura in fotogramma. Oltre dunque a consegnare allo spettatore questo senso di incredibile paranoia (che ha corrispettivi tanto immersivi forse solo nella musica rock), il film richiama alla “materialità” della post-produzione come momento non successivo o trascurabile, ma tecnico, fisico e intellettuale, quanto e più della ripresa, ottenibile anche riponendo una videocamera per terra in un pollaio. In questa dissezione del medium cinematografico, resta la spaventosa sensazione kierkegaardiana che possiamo ancora esperire tutto, e rispetto al potenziale, non abbiamo ancora davvero visto niente.
Voto: ****
Il secondo film proiettato è realizzato da alcuni studenti del collettivo canecapovolto, e si intitola Il lato inaccettabile della libertà: è di fatto un lavoro attribuibile a canecapovolto, visto come rispetta i dettami della loro visione del Cinema. La sottile ironia delle voci fuoricampo (metalliche e inespressive) e delle scritte in sovraimpressione non richiama più il solo Godard o i più eccelsi montatori di materiale d’archivio (Gianikian e Ricci Lucchi), ma anche il Jorgen Leth del The Perfect Human. Forse l’esperienza è meno avvolgente del solito, ma ragiona sul loop come modalità di superamento del Reale, e di fuoriuscita dallo stesso: l’esperienza è sufficientemente labirintica dal non capire, anche quando alla fine lo schermo è nero, se è davvero finita, o non è ancora nemmeno iniziata.
Voto: ***
Per vedere le altre giornate



Non ci sono commenti.
Ultimi commenti Segui questa conversazione
Commenta