Day 2
Si parte con l’avanguardia sperimentale di No es homosexuale simplemente el homofilo sino el cegado por el falo perdido di Equipo Palomar e con il documentario ballerino Paris is voguing di Gabrielle Culand, alle 16.
Il primo è un oggetto particolare di medio interesse che sembra accumulare citazioni letterarie e filosofiche (da Lacan a Pasolini) più per voglia di urlare addosso allo spettatore che non per costruire un discorso coerente e affilato (che era probabilmente nelle intenzioni iniziali). Sebbene la deriva verbosa abbia per lo più la meglio, il film stesso sembra deriderla: infatti le immagini degradano verso una sempre maggiore frammentarietà, con accompagnamento musicale che maschera i momenti più amatoriali, e la stessa voce fuoricampo finisce per ripetere volutamente le stesse cose in istanti ripetuti come piccoli ansiogeni loop nell’attesa spasmodica di un orgasmo che ci consegnano alla fine lo schermo nero del finale e l’ammiccamento caravaggesco che trasforma in maniera improbabile Medusa in uno “sciolto” à la Dalì.
Voto: ***
Decisamente più infelice l’esito qualitativo del documentario della Culand. Avrebbe forse dovuto cercare maggiore spazio per il coinvolgimento dello spettatore (in media assolutamente profano del ballo chiamato vogue), e nonostante la vivacità di certi contesti sembri rendere il film più accogliente (i due concorsi, che dimostrano una media consapevolezza nel montaggio), alla fine il film stesso si riduce ad un autocompiacimento che pare allontanarci dal diverso, piuttosto che avvicinarci allo stesso.
Voto: **
Alle 18,30 è la volta del documentario di Nathaniel Walters sul performer Franko B.. Si intitola Because of Love, dal nome di una performance recente dell’artista, ed è un testo informativo piuttosto di parte (sembrerebbe quasi su commissione) che si guarda più per l’eventuale interesse nei confronti di Franko, piuttosto che per un eventuale interesse cinematografico. Infatti il film non fa altro che riportare in montaggio i filmati delle performance, accumulare interviste che celebrano l’arte di Franko B., e raccontare la sua vita per piccole pillole canore ridondanti e un po’ paracule, senza alcun tipo di pretesa o spinta originale se non forse qualcosa nell’impianto sonoro. L’effetto traumatico delle performance arriva comunque, ma non certo grazie alla faciloneria con cui vengono raccontate e spiegate. Si parla infatti tanto di contesto storico, ma non si riesce a creare un confronto costruttivo con l’Arte contemporanea di allora, se non per sprazzi e antitesi (il parallelo con l’Azionismo viennese viene bruciato subito come pretestuoso). E alla fine rimane poco.
Voto: **
Alle 20,30, è giunto il turno di Bruce LaBruce, che, duole dirlo, in parte delude. The Misandrists parte come un parodistico mash-up del The Beguiled di Don Siegel e di The Wicker Man. Dopodiché si trasforma in una versione ammaestrata delle prime opere di LaBruce (soprattutto The Raspberry Reich e Otto; or Up With Dead People) riproponendo stesse trovate e stesse conclusioni, ma con una confezione più leccata e kitsch che non offre spunto per interessanti riflessioni estetiche, ma rende l’esplosione vitale tipica del cinema di LaBruce decisamente più accomodante e accogliente. Al confronto con opere più per tutti come Gerontophilia, certo, The Misandrists esce bene: è divertente, a tratti spassoso, e pieno di rimandi (da Sunset Boulevard e dall’uovo dell’Impero dei sensi di Oshima, fino a Kenneth Anger citato nella battuta di una ragazza rispetto a Inauguration of the Pleasure Dome). Per chi ha visto poco, può apparire addirittura anarchico. Peccato che essendo sostanzialmente Pop Art, il cinema di LaBruce non risulti proficuo quando concettualmente ridondante, e le citazioni stesse rimangono iconiche, coerenti sì, ma senza quel quid che in altre opere di LaBruce (vedasi Pierrot Lunaire) aveva fatto la differenza.
Voto: **1/2

The Misandrists (2017): locandina
Ed eccoci dunque al capolavoro della giornata, nonché primo film in concorso ad essere proiettato: Jours de France di Jérome Reybaud, viaggio geografico nei territori della percezione. Il gay flauner Pierre vive di conoscenza in conoscenza, senza una meta precisa, accumulando esperienze e ottenendo da esse fondamentalmente una riconferma continua della sua infinita solitudine. Pur partendo da presupposti antonioniani, il film prende una piega più personale puntando sulla fotografia (chiaroscurale caravaggesca) e sul sonoro per immergere in un ritmo squisitamente onirico, ottenuto con stacchi di montaggio repentini e violenti, che per esempio interrompono la musica diegetica sul più bello e fanno ripiombare in una realtà da cui ci sentiamo letteralmente avvolti. Come se dall’eccesso di realismo, Jours de France tirasse fuori la magia.
Il che dimostra che più che ad Antonioni, dovremmo forse guardare al Jacques Tati di Playtime, di cui Reybaud riprende lo splendido gusto per gli articolati piani-sequenza, l’attonita ironia grottesca, la precisione puntigliosa e l’idea dell’estensione cosmica di un Concetto di base, in Playtime il Comico, in Jours de France la Solitudine. Fatto di piccole situazioni spesso talmente private di orpelli da risultare miracolosamente essenziali, Jours de France è un’esperienza che forse richiede pazienza (non certo per chi scrive) ma la ripaga ampiamente.
Voto: ****

Jours de France (2016): locandina
Day 3
Giornata ancor più proficua ed entusiasmante della precedente, il 26 maggio cinefilo è partito già dalle 14 con El futuro perfecto, di Nele Wohlatz, in concorso; pellicola argentina ricca di interessanti spunti teorici (un po’ a discapito dell’empatia coi personaggi). Al regista infatti interessa il linguaggio (parlato, artistico, visivo) e la mise en scène nel senso letterale del termine, dunque non disdegna un certo schematismo di base prima per stendere una mappatura percettiva che orienti lo spettatore, dopo per lanciarlo ad un incrocio metanarrativo in cui la protagonista si ritrova a descrivere i suoi possibili futuri con una conseguenzialità logica tipica di una lingua parlata, o di un’analisi grammaticale. Alla fine il film respira letteralmente di sequenze essenziali e dirette, prive di orpelli, in cui l’opera di scarnificazione degli eventi è tradita solo dagli espliciti assunti teorici di cui sopra, e dunque arriva al cervello senza passare dai sensi. Squisitamente imperfetto ed entusiasta, un esperimento che si concede l’effetto ad hoc solo nell’efficace, metaforica, sequenza finale.
Voto: ***1/2

El futuro perfecto (2016): Xiaobin Zhang
Ancora più curioso e controverso il film in concorso The Beach House di Roy Dib, da confrontare opportunamente con il corto Mondial 2010 che al Sicilia Queer vinse la sezione cortometraggi nel 2015. Se Dib lì trovava negli ambienti e nella percezione degli stessi da parte del protagonista invisibile una sorgente di ansia e inquietudine, in The Beach House invece la fonte di inquietudine sembra essere direttamente nei volti degli esseri umani. Se Mondial 2010 vantava un formato mockumentary che rende l’opera ruvida ed efficace, The Beach House preferisce la strada della finzione tout-court e in particolare del dramma da camera, in cui in unità di luogo e quasi di tempo quattro personaggi si confrontano, giocano e si tradiscono. Ancora una volta, il cinema di Dib si rivela discorso formale preciso e ineccepibile, fondato sui movimenti di camera e sulle incertezze dei punti di vista. I personaggi del film letteralmente traballano fra il fuoco e il fuori-fuoco, e la cinepresa trema indecisa fra un volto e un altro riuscendo a scoprire vibrazioni cinematografiche in una situazione tipicamente teatrale. Tremando fluidamente fra campo e fuoricampo (in una corrispondenza precisa fra incertezza delle proprie idee e incertezza dello stesso stare al mondo), i personaggi alla fine si riducono a movimenti e azioni apparenti e insignificanti: a tal proposito, di straordinaria coerenza formale la sequenza del “girotondo” sulla scogliera, letteralmente interrotto dal bordo sinistro dell’immagine. Come a dire che alla fine i protagonisti non sanno davvero cosa e come hanno vissuto quanto noi abbiamo visto, né noi siamo in grado di decifrarli (e disporli, fisicamente, nello spazio): un film sull’impotenza dell’autore e dell’immagine nel sondare il mondo, il reale e i sentimenti.
Voto: ****

The Beach House (2016): locandina
Alle 18,30 è toccato al terzo film in concorso della giornata, Los objectos amorosos, che a fronte dei pochi mezzi a sua disposizione affronta l’amatorialità imponendosi un rigore realistico costante. Ma Adriàn Silvestre tiene sempre troppo a distanza, e il suo non riesce ad essere un film sul reale, perché quest’ultimo lo vediamo continuamente avvolto e ricoperto dalle “inquadrature”. Al posto dell’identificazione emotiva, troviamo uno schermo piatto; e viene offerto più alle orecchie che agli occhi. Prevedibile e senza stile, un film francamente noioso ed evitabile, in cui l’amour fou è dato per scontato e ha conseguenze banali e inevitabili. Unico pregio: un finale improvviso e brutale. Scena più bella: il racconto dell’amica della fuga dalla Bolivia, in cui ci ritroviamo ad ascoltare come la protagonista che è disposta strategicamente fuoricampo.
Voto: **

Gli oggetti d'amore (2016): locandina
Alle 20,30 sono stati proiettati i quattro lavori più recenti di Gabriel Abrantes, presente in sala a rispondere alle curiosità del pubblico. Visti in ordine anti-cronologico, è stato mostrato:
1) Os Humores Artificiais, uno Short Circuit tenero e folle, romantico e atipico, in cui partecipiamo alla rara esperienza di grossi effetti speciali fantascientifici al servizio della ricerca autoriale più estroversa (voto: ***)
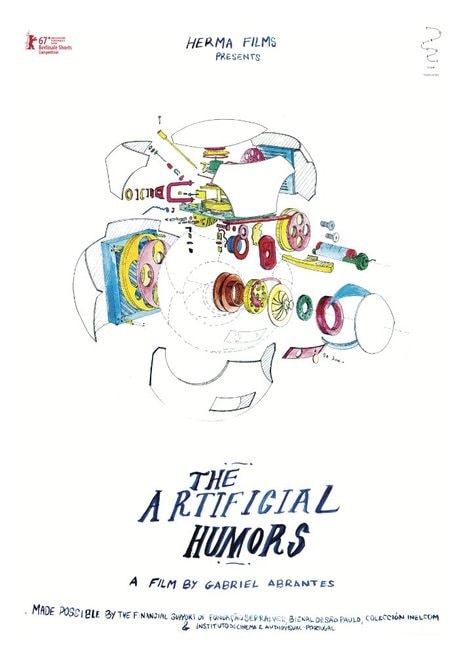
Os Humores Artificiais (2016): locandina
2) Piccolo ed esilarante, The Brief History of Princess X pare citare direttamente Arancia meccanica rendendo protagonista una statua a forma di dildo d’oro gigante, opportunamente ottenuto deformando i lineamenti di un ritratto statuario pre-esistente: irracontabile e ammiccante, un gioiellino (voto: ***)

A Brief History of Princess X (2016): Joana Barrios
3) Di maggiori pretese è stato forse The Hunchback, impossibile punto di incontro fra il videogame Assassin’s Creed, la Trilogia della Vita di Pasolini e il Big Brother orwelliano. Brillante e spiritoso, ma con un ritmo meno sostenuto degli altri corti, e con soluzioni visivamente più sporadicamente efficaci (voto: **1/2)

The Hunchback (2016): scena
4) Infine, Freud und Friends, esilarante pastiche per il quale si rimanda al post del Sicilia Queer dell’anno scorso (qui) (voto: ***1/2)

Freud und Friends (2015): scena
Grandissima attesa c’era in seconda serata per il discusso Rester vertical del concorso Cannes 69 (che si rivela essere col passare del tempo uno dei concorsi più ricchi e importanti degli ultimi anni). Presentato qui al Queer fuori concorso, il film di Guiraudie è un film spoglio e grottesco, che mira a una ridefinizione estrema e pluristratificata dell’evento filmato. Un film non semplicemente realista, ma così serrato nella logica conseguenziale degli eventi e nella logica delle immagini, da lasciare lo spettatore tramortito, ipnotizzato e annichilito. Il film non è affatto scioccante per le sequenze estreme mai volgari, ma cerca piuttosto un’essenzialità dell’immagine che nel montaggio rimanda direttamente a un qualcosa di invisibile e trascendente: il modo più estremo e privo di compromessi per esprimere delle tematiche, o per raccontare una trama, senza rinunciare alla forma. In questo senso, in Rester vertical si parla prima di frustrazione (la prima ora ricca di spunti dumontiani), poi di esplosione del desiderio, e infine delle conseguenze del desiderio (che rasentano la follia e l’isteria); la vera insidia è che le tre cose sono raccontate nello stesso modo. Con un procedere fluido molto curato ma non esibizionistico, il film è un concentrato silenzioso di grottesco e di assurdo, che rimanda non tanto allo star verticali, dritti e forti del titolo (evidente il riferimento nel finale), ma rimanda alla linearità e al rigore della mise en scène, tesa come una corda di violino sempre più sfibrata, sottile, implosa.
Voto: ****
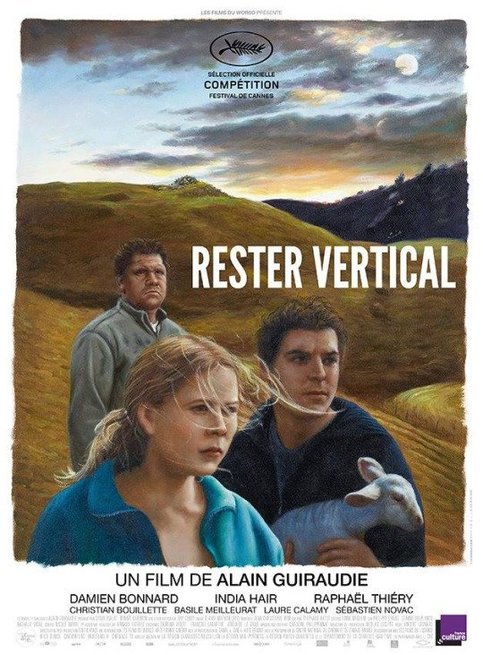
Staying Vertical (2016): locandina
Per vedere le altre giornate



Non ci sono commenti.
Ultimi commenti Segui questa conversazione
Commenta