Dopo il precedente post, in cui mettevo in evidenza le qualità artistiche delle colonne sonore del compositore giapponese Toru Takemitsu, questa volta vorrei scrivere più in generale del rapporto che si crea nel cinema tra musica e immagine e di come (forse) possa essere meglio compreso o perlomeno percepito. È una sorta di "bigino" piuttosto semplificato di ciò che insegno al corso di laurea triennale ai musicisti e/o compositori che vi si iscrivono. Non ha quindi assolutamente le pretese di essere esaustivo né troppo specifico. È rivolto anche e soprattutto a chi di musica non ne sa una mazza, o quasi… sono meri spunti di riflessione, per chi ne avrà voglia.

Esistono principalmente tre modelli di tipologia musicale applicati al cinema - da quello più commerciale, diciamo volto all'intrattenimento, a quello più impegnato, autoriale, meno omologato - che, combinandosi, danno luogo a ulteriori sottogeneri.
1) C'è la forma tradizionale della musica composta per il film, cioè il caso dove il regista chiede al compositore di creare qualcosa di efficace e in qualche modo malleabile (ma non per questo necessariamente personale). Un materiale originale (in quanto non preesistente) che consenta di seguire con notevole coincidenza e coerenza la poetica di base del film e i suoi sviluppi.
All'interno di questa tipologia esistono poi due correnti di pensiero (ovviamente sto estremizzando):
- la prima asserisce che la migliore colonna sonora possibile è quella che nel migliore dei casi quasi non si avverte, o che comunque non prevede di prendere il sopravvento sulle altre componenti dell'opera filmica, o che al contrario viene anche chiaramente percepita, a patto che non la si ricordi come un elemento indipendente e separato dal resto (col rischio che molto spesso la musica scorra come un magma sonoro indistinto e quindi poco memorizzabile… Però, come detto, se essa ottempera alla sua funzione, non intralciando ma supportando l'opera tutta, in fin dei conti ben venga). Quindi, a partire dall'avvento del sonoro, si può andare da una sonorizzazione più o meno percettibile e costante delle immagini, praticamente senza interruzioni per tutta la durata del film (risultando magari un po' asettica, fors'anche in conseguenza del suo utilizzo, fino a quel momento, di mero e intercambiabile accompagnamento in sala di molte pellicole del cinema muto), per finire, nel peggiore dei casi, al clangore insopportabile di alcuni blockbuster (in senso stretto e lato) odierni.
Convenzionale:
Ingombrante
- Di segno opposto, la seconda prevede che la musica, pur essendo parte omogenea e integrante delle immagini, debba comunque avere un carattere distintivo proprio, una sua qualità intrinseca. Questa è una tendenza che si afferma veramente solo verso la fine degli anni '50, quando comincia a far capolino sempre più insistentemente il cosiddetto cinema d'autore (con ovvie eccezioni già apparse prima di allora, come ad esempio i leit-motif dei film di Chaplin, Il Terzo Uomo, alcuni dei film che prevedono come compositore Bernard Herrmann, ecc.)
Più astratta
Più melodica
2) La seconda tipologia prevede la selezione e il riutilizzo di materiale spesso eterogeneo e già edito, cioè il caso in cui al regista serve un consulente musicale (che in alcuni casi può coincidere col regista stesso). È però verosimile che questa volta le immagini debbano cercare di adattarsi alla musica scelta che, in quanto fissa e predefinita, è evidentemente meno malleabile (a meno di non doverla spezzettare).
Eterogenea
Spezzetata:
3) Il terzo modello, più raramente utilizzato nella sua forma più pura, rifiuta in qualche modo la musica come materiale da adattare alle immagini (e viceversa), recuperandola, se necessaria, come elemento diegetico, ovvero come parte realmente integrante all'interno del film stesso, in sede di progettazione e di realizzazione. La colonna sonora diventa quello che accade realmente in una scena: un personaggio ascolta un disco o un concerto dal vivo, accende la radio, ecc.
Rappresentata:
Reale e posticcia al contempo
Come già accennato questi tre modelli spesso si incrociano, quindi nel primo caso, accanto a una colonna sonora composta appositamente, può accadere che si senta il desiderio di utilizzare un brano preesistente in una interpretazione inimitabile, oppure che lo stesso brano venga sottoposto a un nuovo arrangiamento, reincidendone una nuova versione diversa dall'originale (1+2).
Oppure all'interno della seconda tipologia ci si renda conto che, usando solamente materiale già predefinito e quindi meno adattabile, si vengano talvolta a formare dei buchi, colmabili esclusivamente attraverso la composizione di raccordi musicali ad hoc (2+1). Un esempio classico è un film con un'ambientazione temporale specifica che viene determinata anche o soprattutto dall'utilizzo di canzoni che fanno riferimento a quel periodo storico, che però necessita in alcune scene di un commento musicale non connotativo in tal senso…tipo, che so (un esempio fra tanti), la bella colonna sonora originale per violoncello della riuscitissima e inquietante serie tv "The Americans", ambientata, attraverso costumi, scenografie e canzoni appunto, negli anni '80.
Un genere filmico come il musical può tranquillamente accogliere al suo interno tutte e tre le varianti (1+2+3), come nell'esempio qui sotto dove un brano già esistente e sottoposto a una nuova versione (2) viene rappresentato sullo schermo (3), possedendo anche una funzione diremmo extra-diegetica di commento alla storia:
Per quanto riguarda la terza possibilità, la volontà di negare alla musica (nella sua accezione più tradizionale, a proposito di colonne sonore) la funzione di amplificatore o accompagnatore di emozioni, se non nel caso di una sua reale presenza all'interno del film stesso, costringerà il regista alla costruzione di un'opera le cui immagini sono già di per sè autosufficienti, valorizzando al massimo, nel missaggio finale, le caratteristiche musicali dei suoni e dei rumori registrati durante le riprese attraverso la presa diretta (o ricostruendo in post-produzione un affresco sonoro artificiale, cosa oramai sempre più in disuso).
Alcuni illustri casi di tale applicazione si possono trovare in molti autori "contemporanei" di lingua francese, di discendenza tipicamente bressoniana (Daredenne, Dumont, Zonca) o nel movimento cinematografico Dogma 95 creato da Lars Von Trier. Al di là delle esigenze artistiche specifiche, questo è un fenomeno sempre più diffuso, anche grazie alla (o a causa della) notevole diminuzione dei budget da dedicare alla realizzazione delle colonne musicali originali, per non parlare di quelli che devono comprendere (anche) l'acquisto di costosissime liberatorie per l'utilizzo di brani editi, non necessariamente famosi.
Questo tipo di rappresentazione (diegetica) della musica, in contesti meno radicali, realizzata quindi in maniera più artificiosa della pura e semplice registrazione della realtà (ma non per questo meno efficace, dipende dal contesto), può cambiare rapidamente (e continuamente) di segno non appena prende funzione di commento (extra-diegetica) e viceversa:
Fine prima parte
P.S.: nel prossimo post (scriptum, he, he…) affronterei la spinosa questione: quando c'è da parlare di musica, registi, montatori e musicisti in che "lingua" parlano? Il conseguente avvento della croce e delizia delle cosiddette temporary soundtracks; la differenza tra cover e sound alike, e via di questo passo…ma soprattutto l'annosa domanda: il bravo compositore di colonne sonore deve essere per forza un bravo compositore tout court? In altre parole…è più un artigiano o un artista? o una bestia diversa? o solo una bestia?
…e come dicevano i personaggi del mitico serial inglese Il Prigioniero, dalla colonna sonora piuttosto variegata ma memor(izz)abile:
"Be seeing you."

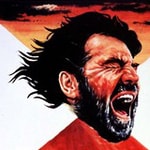

Non ci sono commenti.
Ultimi commenti Segui questa conversazione
Splendido "bigino"!
Grazie mille giovenosta :)
Un caloroso applauso da parte mia.
Ciao Giovanni, bella iniziativa!
Ciao, Gio! (spero mi scuserai l'abbreviazione: poiché sul sito è d'uso salutarci con il nick - personalmente, uso il nome proprio solo in privato - la contrazione mi sembra appropriata). Ti ho letto (e riletto) ben volentieri. Senza, oggettivamente, mai intervenire. L'analisi è effettivamente dettagliata; direi puntuale. Tuttavia, per i modesti mezzi di mia conoscenza, vorrei parlare di un aspetto appena trascurato: l'imposizione della musica. In linea di massima, anche quando i registi hanno suonato (prendo un nome, magari minore, a caso: Alex Infascelli), raramente sfruttano questo aspetto per il proprio lavoro. Eh, sì: per un regista, a volte, la musica appare un sovrappeso. Può, e certamente deve, accompagnare un'opera, ma più spesso la soffoca. Se gli esperimenti dei fratelli Dardenne ("Il figlio") hanno suggerito un'idea non musicale (e qui non parlo di colonna sonora, che, come noto, è qualcos'altro), anche autori come Lynch hanno cercato "inventando" il sound-design di affrancarsi dall'accompagnamento sonoro semplice. Il rapporto tra cinema e musica è disgraziatamente complicato: pare quasi che l'immagine, pur dotandosi di melodia, la respinga, cercando di porre un freno all'abilità del musicista. Storicamente, proprio per evitare questa sovrapposizione scomoda, autori come Chaplin e Carpenter hanno musicato i propri film, pur non essendo completi come musicisti; ma anche in tempi recenti ("L'uomo in più"), autori come Paolo Sorrentino hanno fatto (quasi) da soli. In genere, però, laddove esiste un produttore che promuova il film (Truffaut, per dirne una, essendo produttore delle proprie opere, orientava i suoi compositori: oggi, addirittura, si dice che non vi siano sostanziali differenze tra Maurice Jaubert e Georges Delerue, e quando utilizzava l'uno o l'altro...), questi - il produttore - impone il musicista. Primo, perché (soprattutto se ci si orienta verso contributi economici, a qualsiasi latitudine, la troupe - anche da post-produzione - deve "avere un nome"; secondo, perché nella giungla dei diritti d'autore è difficile essere davvero liberi. Tuttavia, ciò non è sempre un male: Ennio Morricone racconta che Pasolini non chiese nulla, quando lo incontrò ("Maestro, faccia lei", ed andò via) e venne fuori una delle migliori colonne sonore italiane ("Il Decameron"), ma, in generale, lo possiamo dire ? Un regista tollera, piuttosto che "accettare" necessariamente un compositore (emblematici i casi di Kubrick , soprattutto di Lucas - per fare "American graffiti" senza un compositore, ma solo con musiche "da radio" si inimicò mezza Hollywood) . Diverso il caso di "film di genere": quello, ebbene, senza musica non funziona (cosa sarebbero, per dire, "L'esorcista" oppure "Profondo rosso", senza colonna sonora ?). Ma, alla fine, la domanda - lecita ritengo - resta: la musica dà al film ciò che il film chiede ? Un carissimo saluto, M
domanda lecita e osservazioni molto sensate, caro maurri.
per ora, come spunto di riflessione, ti risponderei così: forse si potrebbe aggirare la questione dicendo che in realtà la colonna sonora di un film è TUTTO ciò che essa comprende, ovvero la musica in senso stretto (originale o edita), più il sound design e la presa diretta. ci saranno sempre dei film che sono più sbilanciati verso una o le altre parti (o che le equilibrano tutte, proprio come Lynch). sarebbe bello pensare che se la scelta viene fatta verso il non utilizzo della musica, non sia stato per sottostare a mere ragioni di budget, ma per precise esigenze poetiche.
il mio post-bigino finisce con la dicitura "fine prima parte". per questioni di (mio) tempo e "spazio" (del sito) forse non potrò mai entrare così nello specifico come chiedi (potrei parlare per ore di ciascuna delle questioni da te sollevate, quindi giorni di scrittura), ma se avrai "pazienza" (non sarà domani, per dire), intanto prendo nota, quindi includerò anche alcuni tuoi spunti nei post successivi.
parlo al plurale perché nelle intenzioni potrebbero essere svariati. dipenderà anche dall'interesse che via via susciteranno. un caro saluto, gio.
Post estremamente interessante per contenuti e perché genera immediatamente un senso di impaziente attesa per il prossimo "pezzo". Personalmente c'è il desiderio/auspicio di trovarvi un qualche accenno a quei casi (straordinariamente affascinanti a mio avviso) in cui la colonna sonora, aldilà della mera "funzione di amplificatrice o accompagnatrice (o scatenatrice) di emozioni", è stata incaricata di un ruolo più squisitamente linguistico, ossia come vero e proprio veicolo sintattico delle immagini. Solo per citare qualche variegato esempio che mi pare rientri nella categoria (ovviamente le caratteristiche "tecnico/narrative" sono assai disparate fra loro, ma il filo conduttore semiotico è il medesimo): gli acclarati binomi Welles/Herrmann, Hitchcock/Hermann, Leone/Morricone, Kiezlowski/Preisner o i meno noti (e non meno importanti) ultimi polar di Melville o il miglior cinema di Ophuls e via dicendo. Con i migliori elogi. Un saluto.
...e Greenaway/Nyman, P.T. Anderson/Brion prima e Greenwood poi, Antonioni/Fusco, Teshigahara/Takemitsu, Tran Anh Hung/Tiêt Tôn-Thât...ci saranno un po' di puntate, nelle previsioni. se avrai pazienza spero verrai ricompensato...;-) se vuoi divertirti, nel frattempo leggi il mio anatema contro Whiplash, il film SULLA musica del momento. a presto e grazie per gli elogi.
Commenta