«Il regista giusto – l’unico possibile, anzi – per questo tipo di materiale». Se a pronunciare queste parole è Roger Ebert, beh, c’è da credergli. In effetti, è pressoché impossibile comprendere la grandezza di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema senza fare riferimento alla biografia di Scorsese, un ragazzino italoamericano malato di attacchi di asma, che si sentiva vivo solo in chiesa e al cinema, e che, dalla finestra, guardava i gangster – piccoli e grandi – del suo quartiere. Uno dei motivi per cui questo capolavoro abbia fatto la storia è il grande tasso di empatia che lo spettatore riesca a stabilire col protagonista, Henry Hill (il miglior Ray Liotta di sempre, che fece di tutto per avere la parte). Il fascino che il gangsterismo spiccio anni Cinquanta esercita sul ragazzino Henry di Brooklyn è, di fatto, il medesimo che provava il ragazzino Martin: il fascino perverso del potere, della criminalità organizzata che penetra lì dove lo Stato è più assente, dove l’istruzione è meno diffusa, dove la qualità della vita è più bassa, e che porta un ragazzino a sognare ad occhi aperti una vita fatta di rispettabilità, parole d’onore, donne, feste, eccessi. Un riscatto sociale basato su un patto col diavolo – sangue, lealtà, tradimenti, etc. – ma che sembra l’unica strada possibile per poter davvero cambiare vita in un’America in cui gli ascensori sociali sono fermi. È tutta qui la grandezza di GoodFellas, il cui sguardo straordinariamente documentaristico contribuisce a rendere questa parabola perversa di dannazione ancor più efficace. A Scorsese non interessa affrontare il discorso dei grandi gangster, delle grandi famiglie che, in maniera quasi partitocratica, si spartivano i business illegali degli USA e che, quando le circostanze lo richiedevano, si facevano la guerra. A Scorsese non interessa la politica gangsteristica dei pieni alti: il focus è la manovalanza del crimine. Henry Hill non è Michael Corleone. Henry Hill non è il figlio buono di un grande boss che viene attratto da forze del male più grandi di lui e che finisce per diventare cattivissimo in nome di un concetto deviato di ‘famiglia’. Henry Hill è l’uomo qualunque, il ragazzino qualunque che vive e respira un ambiente malato – che per lui è la normalità, non avendo mai vissuto o aspirato a nulla di differente – in cui i gangster detengono il potere. Un potere diverso da quello delle grandi logiche della spartizione dei traffici illegali, un potere forse prosaico (parcheggiare l’auto ovunque, avere un tavolo in un ristorante in qualsiasi momento, spadroneggiare ovunque) ma ugualmente ammaliante nella sua intensità. Un potere in cui il timore riverenziale degli estranei, pur non essendo mai davvero affetto, riesce ad essere gratificante in maniera orgasmica. È una storia vera quella di Henry Hill, come vero è l’ambiente che l’ha resa possibile, come vere sono le dinamiche che Nicholas Pileggi delinea nel suo giornalistico Wiseguy: Life in a Mafia Family. È questa veridicità ad attrarre Scorsese, che firma il suo sesto capolavoro, co-sceneggiato con Pileggi stesso, in appena ventitré anni di carriera. La regia frenetica di Scorsese in cui canzoni, parole, gesti sembrano tutti far parte di un’organica allucinazione collettiva compie un ulteriore step in termini di maturità espressiva. Vedere, per credere, il celeberrimo piano sequenza dell’ingresso di Henry e Karen (una grandissima Lorraine Bracco) al Copacabana Night Club, perfetto nel suo perpetrare l’idea di una doppia seduzione: quella di Henry su Karen e quella, perversa, della vita criminale (o, meglio, del potere anche prosaico della vita criminale) su Henry. Ma non manca neanche Hitchcock: il “Vertigo Effect” viene usato magistralmente da Scorsese nella scena in cui Jimmy Conway (un De Niro quasi sprecato nella sua straordinarietà), seduto in una tavola calda con Henry, sospetta, senza darlo a vedere, che quest’ultimo sia divenuto un informatore della polizia. Tale tensione latente viene resa con una carrellata indietro e una zoomata in avanti di una lentezza esasperante che rende perfettamente l’ambiguità viscida di lealtà e tradimento della vicenda, dove bene e male sono ormai irrimediabilmente confusi e i nodi del cappio della verità si stanno lentamente stringendo su Henry. Gara di bravura del cast, persino i personaggi secondari sembrano attori di consumata esperienza e talento, ma a vincere su tutti è Joe Pesci, che torna a lavorare con Scorsese a dieci anni da Toro Scatenato e lo fa al massimo livello: se non ci fossero titoli di testa e di coda, si penserebbe che sia un gangster vero.
Voto: 10
Rilevanza: 4. Per te?
Sì
No











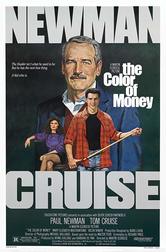
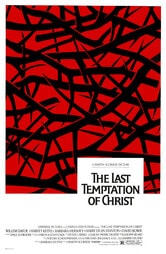



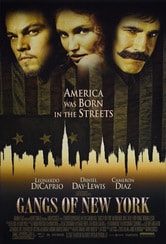




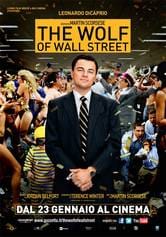



Non ci sono commenti.
Ultimi commenti Segui questa conversazione
Commenta