Elephant
- Drammatico
- USA
- durata 81'
Titolo originale Elephant
Regia di Gus Van Sant
Con Alex Frost, Eric Deulen, John Robinson, Elias McConnell, Jordan Taylor
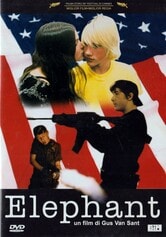

Titolo originale Elephant
Regia di Gus Van Sant
Con Alex Frost, Eric Deulen, John Robinson, Elias McConnell, Jordan Taylor
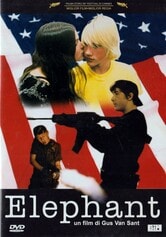
Titolo originale Sideways
Regia di Alexander Payne
Con Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virginia Madsen, Sandra Oh
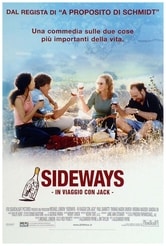
Titolo originale Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Regia di Michel Gondry
Con Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Mark Ruffalo, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson

Bastano pochi minuti allo spettatore più avvezzo per capire come le visionarie e surreali immagini di “Se mi lasci ti cancello” non potevano che fuoriuscire dalla mente folle e a suo modo geniale di Charlie Kaufman, lo sceneggiatore dell’incredibile “Essere John Malkovich” e del premiato (ma molto meno efficace) “Il ladro di orchidee”. Se a ciò si aggiunge il tocco naif del regista Gondry, il quadro è completo.
A dispetto del suo fuorviante e terribile titolo non è quindi la consueta sciapita commediola sentimentale ma un film figlio "in tutto e per tutto" del suo sceneggiatore, più ancora che del suo regista, ennesimo strampalato viaggio nella mente dei suoi bizzarri protagonisti, una sorta di dramma triste e malinconico dove è bandito tutto ciò che è convenzionale.
La curiosa ed originale trama vede i due protagonisti Clementine (una Kate Winslet molto in parte) e Joel (un convincente Jim Carrey) essere una sui generis coppia apparentemente felice. Almeno sino a quando Joel scoprirà che improvvisamente Clementine ha deciso di “cancellarlo” letteralmente dalla sua memoria, affidandosi ad una fantasiosa società specializzata in tali inverosimili trattamenti. Ferito, disperato, deciderà di fare lo stesso passo, salvo però ricredersi ad esperimento iniziato.
Coloro che si aspettavano di assistere ad uno spettacolo divertente con al centro l’istrionico Carrey rimarranno quanto meno spiazzati davanti ad un soggetto tanto stravagante.
Quelli invece che riusciranno a "stare al gioco", apprezzeranno questa intelligente storia così fuori dagli schemi.
Non so però quanti si affezioneranno sinceramente a tutti i personaggi, e ciò malgrado anche nei ruoli secondari figurino attori più o meno emergenti, come la seducente Kirsten Dunst, il camaleontico (e irriconoscibile rispetto a Collateral) Mark Ruffalo ed Elijah Wood, qui inespressivo quanto nel Signore degli Anelli. UNA MUMMIA.
Insomma, un film sicuramente insolito che diventerà di culto per molti ma dal ritmo francamente troppo lento e la cui storia alla lunga (come già nel “Il ladro di orchidee”) finisce un po’ per ripetersi, anche per la sua eccessiva durata.
Fenomenali comunque i due protagonisti.
Titolo originale The Devil's Rejects
Regia di Rob Zombie
Con Sid Haig, Bill Moseley, Sheri Moon Zombie, William Forsythe, Ken Foree, Matthew McGrory

Innanzitutto partiamo dal titolo. Perche' come al solito la distribuzione italiana ha sfornato un titolo che ha ben poco a che fare con quello originale. "The Devils Rejects" diventa "La casa del diavolo"... Veramente bravissimi. Lo scopo, commerciale, e' chiaro. Da un lato ci si riallaccia al titolo precedente, "La casa dei 1000 corpi" , di cui il film è una sorta di sequel, riprendendone i personaggi. Dall'altro si tende soprattutto a cercare di far andare in sala il maggior numero di appassionati del genere, la parola "casa" è da decenni associata infatti all'horror. Il tutto ha un sapore decisamente squallido e non sarebbe male punire i responsabili di questa ennesima porcheria facendoli passare "una seratina" in compagnia di Otis e Spalding...Che anche in questo film non scherzano affatto. Se ne accorgeranno tutti gli spettatori sin dalle prime immagini di questo brutale, sconvolgente e devastante film che il Metal Rob Zombie ha sfornato tenendo ben presente ancora una volta la lezione impartita negli anni '70 da Tobe Hooper e che deve molto nell'uso del montaggio al miglior Sam Peckinpah, quello del "Mucchio selvaggio" per intenderci. Ma non si tratta di semplici citazioni. Questo duro e spiazzante horror (road/western) movie, è proprio un film degli anni '70. O almeno una copia venuta meglio dell' originale. Esagerazioni ? Forse. Ma la naturalezza e l'efficacia con cui quei favolosi anni (anche per l'horror) vengono rievocati cosi' alla perfezione da "La casa del diavolo" non ha eguali o quasi nella cinematografia recente. Questo sia nelle immagini che nelle sporca e cattivissima messa in scena. Notevole anche la sceneggiatura, (e questa e' una piacevole sorpresa) infarcita di dialoghi taglienti e di acida ironia, che descrivono personaggi folli ma fatti di carne e quindi crudelmente autentici. Fatta eccezione per la sola mamma Firely, troppo ma veramente troppo sopra le righe. Per non parlare della colonna sonora, semplicemente da sballo. E cosa dire del "fisico di ruolo" (traduco "alla Severgnini", vista l'antipatia che provo per i francesi e la loro lingua...) dei protagonisti, tra cui la mozzafiato moglie del regista? Chiaro non è un film "adatto" a tutti i palati, anzi tutt'altro. Il sangue scorre a fiumi. (E come il film sia riuscito a trovare una degna distribuzione è sorprendente. C'e da scommettere che molti, anche durante una visione domestica, non riuscirebbero facilmente a portare a termine la visione.E in effetti la brutalità e la crudezza di molte scene, mai però gratuite o spettacolarizzate come accade (troppe) altre volte, mettono decisamente a dura prova anche lo spettatore più avvezzo.
Titolo originale The Three Burials of Melquiades Estrada
Regia di Tommy Lee Jones
Con Tommy Lee Jones, Barry Pepper, Julio César Cedillo, January Jones, Dwight Yoakam

Quello del divo Tommy Lee Jones è un debutto alla regia di quelli che strappano l'applauso.
"Le tre sepolture" è un film memorabile,cinico, asciutto ed esemplare, intriso di macabro umorismo.
Storia di un'amicizia virile e insieme incontro/scontro di due culture, una stora "di confine" e quindi di razzismo e di violenza, di dolore e di pietà, che rievoca senza inutili dirette citazioni, ma nello spessore, nel respiro e nel suo incedere malinconico, tanto il cinema di Pechinpah quanto quello dell'amico Eastwood.
Recitato alla perfezione, anche nei ruoli di contorno e persino in quelli femminili, fatto raro in un cinema così maschile, (ma su tutti è indimenticabile il personaggio del vecchio cieco chiuso nel suo isolamento, veramente lacerante) fotografato "come meglio non si può" da Chris Menges capace, colorandoli di luce giallo ocra, di drammatizzare i magnifici paesaggi semidesertici presenti lungo il confine tra Texas e Messico, "Le tre Sepolture" trae inoltre la sua forza e la sua particolarità dallo splendido montaggio e dalla fascinosa sceneggiatura "a puzzle" di Guillermo Arriaga, maestro nel raccontare la storia sotto diversi punti vista, in un andirivieni temporale trascinante di matematica precisione, che alla fine mette in ginocchio lo spettatore e lo costringe, al pari del copratogonista, a prendere vera coscienza di sè.
Titolo originale Everything Is Illuminated
Regia di Liev Schreiber
Con Elijah Wood, Eugene Hutz, Boris Lyoskin, Laryssa Lauret, Jonathan Safran Foer

Ogni anno ci sono delle piccole sorprese cinematografiche, e "Ogni cosa è illuminata" dell'attore esordiente alla regia Liev Schreiber è senz'altro una di queste. Solitamente è tutt'altro che facile riuscire a tradurre un successo letterario, ma il regista, condividendone con lo scrittore il carattere fortemente autobiografico, vince la scommessa e costruisce un film che non di rado raggiunge toni poetici, molto toccante e commovente.
Suddiviso in piccoli capitoli come un vero e proprio diario di viaggio, questo atipico piccolo road movie dal sapore agrodolce in terra Ucraina,alterna sapientemente una prima parte di stravagante e surreale comicità, che richiama da vicino il cinema del miglior Kusturica, ad una seconda che, man mano che ci si avvicina all'epilogo ( la scoperta della scatola "casomai") finisce per essere di straziante tristezza e tragicità.
Quando ad un certo punto a Johnatan viene chiesto perchè collezionasse tutte quelle cose, egli risponde che forse lo faceva per "paura di dimenticare".
Surreale e quasi fiabesco, "Ogni cosa è illuminata" è un film che ci invita appunto a non dimenticare, a tener sempre ben viva la memoria del passato, perchè ogni cosa, anche quella più piccola, puo' essere tanto importante da illuminare il cammino della nostra vita.
E subito dopo averlo, visto non si fa fatica ad inserirlo in quella ristretta lista di film, non solo di quest'anno, che proprio non si possono dimenticare.
Titolo originale El laberinto del fauno
Regia di Guillermo Del Toro
Con Ivana Baquero, Doug Jones, Sergi López, Ariadna Gil, Maribel Verdú, Alex Angulo

Titolo originale I'm Not There
Regia di Todd Haynes
Con Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere, Heath Ledger

Per raccontarci non solo i diversi volti dell'uomo e dell'artista Dylan, ma anche il trascorrere del tempo, l'infrangersi dei sogni di un'intera generazione, l'immaginario di un'intera epoca, il regista Todd Haynes, si serve di diversi attori (ottima la scelta del bambino di colore e geniale quella di Cate Blanchett, che lo ripaga di una prova "elettrica" e formidabile per mimetismo) e compone un mosaico insolito e visionario.
La creatività e l'originalità dell'operazione sono fuori discussione.
Ma non tutte le parti di cui è composto il puzzle convincono francamente alla stessa maniera.
Ad esempio quella che ha per protagonista Richard Gere aggiunge ben poco: non per colpa dell'attore (che ha la faccia giusta e si cala anch'egli bene come tutti gli altri nel personaggio) ma della scrittura di Haynes (anche autore del soggetto) qui meno felice.
La frammentarietà della narrazione e suoi diversi registri colpiscono per la maestria sia del montaggio che della fotografia. E ottima è la direzione degli attori.
Ma il film pur se tecnicamente ineccepibile e chiaramente sentito, finisce per dilungarsi eccessivamente e per essere permeato da troppo poco calore. Molto belle le immagini e le parole della scena finale.
A cui seguono, sullo scorrere dei titoli di coda, le note della celeberrima e bellissima "Like a Rolling Stone".
Non c'era scelta migliore per chiudere in modo classico e tradizionale un film comunque affascinante e innovativo.
Titolo originale The Savages
Regia di Tamara Jenkins
Con Laura Linney, Philip Seymour Hoffman, Philip Bosco, Peter Friedman, Gbenga Akinnagbe

Il Cinema Indipendente Americano vive oggi un buon momento. Ne è un esempio “La famiglia Savage”, scritto e diretto da Tamara Jenkins, che dopo l'ottima accoglienza ricevuta all’ultimo Festival di Torino è da qualche giorno sugli schermi di (quasi) tutta Italia.
Si tratta di un piccolo film, delicato, vero.
Racconta, con i giusti toni sommessi, la storia agrodolce di due fratelli che si ritrovono a dover gestire l’improvvisa demenza senile dell’anziano (poco amato) padre. Fatto che li porterà nuovamente ad avvicinarsi, a crescere, a convivere con i sensi di colpa: e ovviamente anche a complicare ancora di piu' le loro vite gia' belle incasinate e piene di frustrazioni, sia professionali che sentimentali.
Il film è narrato in modo sincero, autentico, senza fare troppe concessioni alla retorica, specie nella sua brillante ed intensa parte iniziale. Ed e' privo o quasi (il pianto davanti alle uova) delle furbizie tipiche tanto del cinema Hollywoodiano (vedi il recente “Non è mai troppo tardi”) che di "un certo" Cinema Indipendente, quello costruito ad arte per piacere un po' a tutti (vedi il sopravvalutato "Little Miss Sunshine).
Certamente alla buona riuscita del film contribuisce la presenza del produttore Alexander Payne, già regista del brillante “A proposito di Schmidt”, film tra l'altro affine a questo per tematiche trattate.
Per carità, non tutto fila per il verso giusto, perchè nella parte centrale del film non mancano alcune divagazioni e ripetizioni, alcuni momenti di stanca che lo rendono sinceramente un po' palloso. Ma dove non brilla la regia, arriva in aiuto il fine lavoro di recitazione di tutto il cast. Sotto questo punto di vista, non sorprende certo la prova di Philip Seymour Hoffman, al solito splendido nella caratterizzazione del suo personaggio, un docente di Storia del Teatro perennemente alla ricerca di un riconoscimento accademico: come anche quella di Laura Linney, sulle cui spalle si regge la gran parte del film, nella parte della fragile sorella aspirante commediografa. Ruolo che gli ha regalato una meritata nomination Oscar.
Di pari livello, se non la migliore, è poi l'interpretazione dello scorbutico e anziano padre fatta dal caratterista Philip Bosco: bravissimo. "La famiglia Savage" è in definitiva un buon film, con alcuni passaggi veramente molto belli.
Ad esempio quelli iniziali, con le immagini quasi oniriche della piccola e soleggiata cittadina dell'Arizona in cui viveva il padre: quella in cui la Linney durante l'amplesso (con il piu' che maturo amante) tiene la zampa al cane. Oppure quelli che sottolineano i crescenti sensi di colpa dei due figli, come l'amara conversazione tra loro e il padre al ristorante per decidere "cosa fare" dopo la sua morte.
O ancora quello in cui i protagonisti devono riordinare una stanza sommersa di libri, caotica ma con "una sua logica" e una tazzina da thè finisce per esser spostata "giusto" nel punto dove era situata poco prima.
E anche la scena finale, che non svelo, chiude il film in modo cinematograficamente perfetto.
Titolo originale Eastern Promises
Regia di David Cronenberg
Con Viggo Mortensen, Naomi Watts, Armin Müller-Stahl, Vincent Cassel
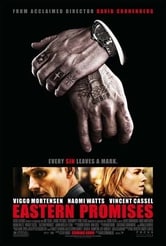
Errore:
chiudi
Non ci sono commenti.
Ultimi commenti Segui questa conversazione
Commenta