Funny Games
- Thriller
- Austria
- durata 103'
Titolo originale Funny Games
Regia di Michael Haneke
Con Ulrich Muehe, Susanne Lothar, Arno Frisch, Stefan Clapczynski
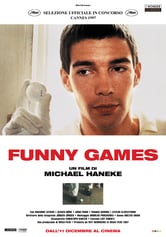

Premessa (che c’entra e non c’entra)
Il cinema è, fin dalle origini, una pratica «violenta». E con questo non voglio intendere la violenza sullo schermo, quanto, piuttosto, dello schermo. Se ne accorsero per primi gli spettatori del cinema delle origini, per cui i fotogrammi, che ingrandivano a dismisura oggetti e persone, che riproducevano punti di vista inagibili all’occhio umano, erano qualcosa di sconvolgente e assolutamente «violento». Per uno studioso come Tom Gunning era, in particolare, il primo piano (l’immagine-affezione, secondo Deleuze) ad essere qualcosa di «violento», uno shock per lo spettatore, che serviva a catturare violentemente lo sguardo e l’attenzione, per condurlo all’interno della narrazione.
Dunque, nel cinema, almeno implicitamente, esiste un’idea di «violenza» interna alle immagini. Alcuni registi sono riusciti, con i loro lavori, a “sviscerare” questa violenza, e a renderla l’oggetto centrale del loro discorso. Un’impresa rischiosa, che spesso si è scontrata con l’accusa di gratuità, di esibizione, di voyeurismo sadico. Certo, i film di questi registi sono, ovviamente, facile preda della critica spicciola, ma hanno il valore indiscutibile di aver messo, su di un piano nuovo, il concetto di violenza, da sempre rigettato, ma da sempre, come scritto nella premessa, intrinseco all’arte cinematografica.
Forse, il più grande esempio di discorso teorico sulla violenza nel cinema – o, come scritto nel titolo, della e nella immagine – è rappresentato dal capolavoro pasoliniano Salò e le 120 giornate di Sodoma. Il film di Pasolini si confronta produttivamente con il testo sadiano, superandolo e facendolo proprio – un testo tra l’altro, per chi scrive, tra i vertici della letteratura filosofica di sempre, per l’impresa di aver spinto, come scrive Adorno, al punto di non ritorno (nel bene e nel male…. anzi, più nel male!) la concezione illuministica dell’uomo. Scrive, a riguardo, Michael Haneke «l’unico che, a mio avviso, è riuscito a rappresentare la violenza in maniera responsabile, è stato Pasolini in Salò. Lì la violenza era quello che è, e questa violenza non si può consumare, a meno che non si abbia qualche serio problema». Una violenza senza fronzoli, senza filtri: la violenza di Salò è violenza, punto. Il nostro rigetto, ci suggerisce Haneke, è l’unica reazione giustificabile. Pasolini ha messo in pratica – concettualmente – un assoluto e mostruoso parallelismo tra la forma e il contenuto. La violenza delle e nelle immagini.
Nel panorama contemporaneo, l’autore che, più di ogni altro, ha sviluppato in maniera teorica il concetto di violenza della/nella immagine è, indubbiamente, l’austriaco Michael Haneke. In particolare, con i suoi primi film – i migliori, per chi scrive – ha analizzato (anche provocatoriamente) il rapporto sadomasochistico e violento che intercorre tra spettatore e film. Culmine della sua ricerca è Funny Games, del 1997. La violenza del film consiste nell’esasperare, fino al parossismo, la condizione subalterna dello spettatore nei confronti della narrazione, come accade nei classici thriller. In più, il film «nega» allo spettatore l’esibizione di questa violenza (nel film nulla è mostrato, tutto è suggerito), appunto per stimolare nello spettatore un giudizio critico: occultare la vista, non concedersi all’occhio, per farci porre domande sul senso di questa stessa violenza. Con fare assolutamente moderno.
Se Pasolini e Haneke sono i due teorici più “colti” della violenza cinematografica, ad un livello più popolare, altri registi ne hanno sviluppato le intuizioni. Due panorami cinematografici in particolare hanno fatto della “violenza” un proprio discorso imprescindibile: il nuovo horror francese e l’oltraggioso e sadico cinema contemporaneo giapponese.
La nuova “onda” francese, che vede come capiscuola registi come Pascal Laugier, Alexandre Bustillo, Julien Maury, Xavier Gens, Fabrice Du Welz, si contraddistingue per un uso eccessivo e disturbante dello splatter e del gore. Pellicole spesso insostenibili – chi scrive non ha retto la mezz’ora finale di Martyrs, tra gli episodi più famosi e più deboli della suddetta onda -, ma che hanno contribuito a riportare come «centrale» un discorso sulla violenza del/nel cinema. Non solo, dunque, accese critiche politiche (Frontiers), o lucide analisi sociali (À l’intérieur), ma anche profonde riflessioni metalinguistiche sul sadismo della visione.
Caratterizzati dal senso della parodia e dell’ironico sono, piuttosto, gli autori giapponesi. Non si può, infatti, negare una certa ludicità nell’opera di Takashi Miike – quint’essenza del sadismo cinematografico giapponese. Ludicità debitrice del manga e dell’anime. Più radicale, invece, Sion Sono, altro autore che mette a confronto la violenza esibita nell’immagine all’interno di microcosmi famigliari pronti ad esplodere. La «violenza» del cinema giapponese si caraterizza, dunque, per un approccio più postmoderno, in quanto condensa elementi che stridono per accomulazione e accostamento.
E gli Stati Uniti? Vorrei citare un film, spesso affiancato a ridicoli baracconate come Saw – L’enigmista o simili, ma che invece, a mio avviso, è un esempio interessantissimo e che meriterebbe una degna rivalutazione: Hostel, di Eli Roth. Un film che pone (anche) la questione della violenza, affrontandola in maniera profonda e consapevole. Non solo un grande atto d’accusa nei confronti del capitalismo americano, ma anche un importante film sulla capitalizzazione dell’immagine (violenta). L’espediente di un gruppo di studenti che si recano in un (trasfigurato) paese dell’est, in cerca di sesso e violenza, e in cui subiranno quella stessa violenza che cercavano, è forse uno dei metodi più iconoclasti per porre la questione dell’immagine violenta al cinema. Pur non rinunciando alla spettacolarità di prodotto commerciale, Hostel mette in campo tutta una serie di problematiche sulla violenza, che sovente il cinema contemporaneo rifiuta e rigetta.
Nella playlist che segue ho inserito alcuni titoli, a mio avviso, fondamentali, per interrogarsi sul concetto di «violenza» al cinema.
Titolo originale Funny Games
Regia di Michael Haneke
Con Ulrich Muehe, Susanne Lothar, Arno Frisch, Stefan Clapczynski
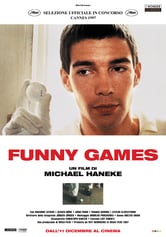
Regia di Pier Paolo Pasolini
Con Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto Paolo Quintavalle, Aldo Valletti

Titolo originale Frontièr(s)
Regia di Xavier Gens
Con Karina Testa, Aurélien Wiik, Patrick Ligardes, David Saracino, Maud Forget

Titolo originale Ôdishon
Regia di Takashi Miike
Con Renji Ishibashi, Eihi Shiina, Ryo Ishibashi, Tetsu Sawaki, Jun Kunimura

Titolo originale Imprint
Regia di Takashi Miike
Con Youki Kudoh, Billy Drago, Michie Ito, Toshie Negishi

Titolo originale Tsumetai nettaigyo
Regia di Shion Sono
Con Asuka Kurosawa, Mitsuru Fukikoshi, Tetsu Watanabe, Megumi Kagurazaka, Denden

Titolo originale Hostel
Regia di Eli Roth
Con Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson, Barbara Nedeljakova, Jan Vlasák

Non ci sono commenti.
Ultimi commenti Segui questa conversazione
Commenta