Regia di Mike Leigh vedi scheda film
The Sun is God (Il Sole è Dio) – James Mallord William Turner
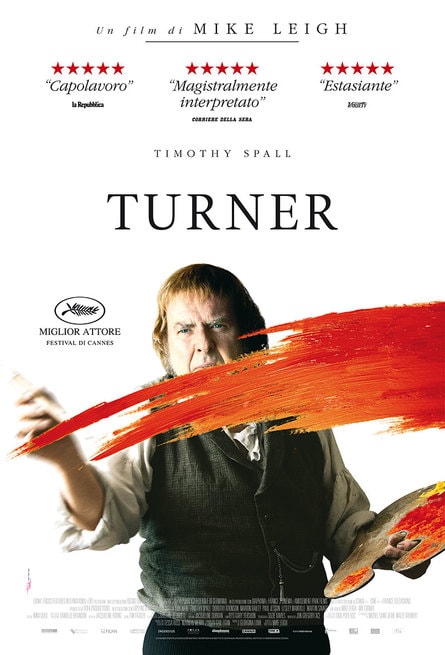
Turner (2014): locandina
L’ultima fatica di Mike Leigh, uno dei massimi esponenti del cinema britannico contemporaneo (e non solo) passata anche da Cannes, dove a me sembra che sia stata apprezzata meno del dovuto da una giuria più orientata verso l’innovazione della forma, è dedicata alla figura del più grande paesaggista inglese di tutti i tempi (Mr. Turner, appunto).
La sua visione delle cose è indubbiamente più tradizionalista rispetto alle innovazioni “formali” del linguaggio portante avanti da molti altri grandi Autori presenti alla rassegna che sono ovviamente altrettanto importanti (e che forse adesso vanno – a buon diritto – anche per la maggiore). Questo a mio avviso però, non dovrebbe essere un impedimento (e mi riferisco pure ai riscontri critici che sono stati abbastanza controversi) a riconoscere il valore di un’opera indubbiamente più classicheggiante, ma comunque meritevole come questa, e dove il regista si conferma bravissimo nel creare architetture di straordinaria presa (visivamente parlando), oltre che nel dare un senso alla narrazione che va ben più in là della semplice biografia (almeno come normalmente viene intesa al cinema) dentro a un racconto pieno di interrogativi e di domande, fra i più difficili e rischiosi da portare a compimento, soprattutto se si sceglie una via così particolare (un biopic d’artista, come lo ha definito Andrea Bellavita, per realizzare il quale il regista ha fatto quello che non ti aspetti e lo ha fatto con impeccabile stile uscendo assoluto vincitore).
Leigh affronta infatti la figura del pittore con la consapevolezza (che non significa reverenzialità) della statura artistico-nazionale che incarna, senza farne però mai un “santino” grazie alla coraggiosa tenuta di una messa in scena al tempo stesso ironica e solenne, spiazzante e classica, ricca e attraente come poche altre, e alla sua particolare maniera di lavorare, che è poi quella di costruire ogni sua opera – compreso questa che forse sulla carta poteva apparire come la meno indicata a seguire pedissequamente il metodo - senza partire da una sceneggiatura preconfezionata, ma da costruire invece “collegialmente” durante le lunghe sedute preparative fatte con gli attori nel corso delle quali si definiscono non solo la struttura portante, ma anche i particolari di ogni sua pellicola.
Il percorso artistico e di vita del grande, innovativo e talentuoso Artista del pennello vissuto negli anni a cavallo fra settecento e ottocento (Joseph Mallord William Turner: 1775, Coven Garden, Londra – 1851, Chelsea, Londra) che con il suo lavoro e le scintillanti nuance dei suoi colori, ha contribuito a reinventare il modo di “disegnare” le immagini sulla tela aprendo così – con largo anticipo - la strada alla modernità della pittura, avanguardie comprese, si sviluppa dunque dentro lo spazio di una rappresentazione che con profonda e partecipata competenza, prova prima di tutto a “penetrare” l’anima dell’uomo attraverso quella dei suoi quadri, al fine di restituirci l’essenza del suo genio proprio attraverso di essi (la pittura per un artista é parte fondamentale del suo essere), dentro a un’esistenza tutto sommato ordinaria e con pochissimi “guizzi” nel privato (persino abbastanza discutibile, se vogliamo).
La scelta in questo è abbastanza radicale, poiché il regista si concentra soltanto sugli ultimi 25 anni della sua vita e sulle difficoltà (anche operative) di affrontare il tema della malattia che lo porterà alla morte, ma tenendo comunque conto anche della relazione profonda che Turner aveva col suo amato padre e delle fratture che si creeranno dopo la sua morte. Il tutto insaporito da una buona dose di humour che solo gli inglesi sanno usare (e dosare) così bene senza mai cadere nel volgare (o addirittura nel banale).
Se vogliamo dunque, non c’è un vero e proprio intreccio, né momenti topici che contribuiscano a far salire la temperatura e l’attenzione dello spettatore. Qui infatti anche gli strappi “emozionali” sono marginali parentesi che si aprono e chiudono nel giro di pochi attimi, ma nonostante questo (ed è tutto merito della regia) ci troviamo di fronte a un film profondamente empatico capace di creare un forte rapporto emotivo con il pubblico in sala.

Turner (2014): Timothy Spall
Per mettere in cinema questo gigante della pittura (un uomo burbero e solitario che sembrava comunicare più con i grugniti che con le parole, paragonato addirittura a un maiale in due brevi sequenze collocate quasi all’inizio del film) Leigh lavora su più piani, e soprattutto indaga le sue opere tenendo conto di una dualità che è anche uno dei noccioli centrali della storia: da una parte la sua straordinaria, “prepotente” capacità di dipingere e rendere palpitanti come mai era accaduto prima, la luce e l’aria, gli spazi celesti e marini, le turbolenze delle tempeste o i corruschi vortici che anticipano le bonacce; dall’altra invece la sua manifesta incapacità di ritrarre il corpo umano invaso dal dolore e di fissare sulla tela la sofferenza e il peso della vita di una giovane prostituta, o di rappresentare la tragedia che si cela dietro alle spoglie di una ragazza morta per annegamento.
Perfetto come sempre anche nel casting, non poteva che optare per dare la giusta sostanza all’eccentrica figura del pittore, a un performer della statura di Timothy Spall (giustamente premiato a Cannes), strepitoso attore anche fisicamente debordante che con l’intelligente aderenza intuitiva del suo strabiliante talento, diventa davvero il perno assoluto del racconto, che in senso figurato si potrebbe definire simile a quello di una immensa antenna catalizzatrice di tutto ciò che succede attorno alla sua figura, compresi gli umori (e le contraddizioni) dell’epoca storica di riferimento magistralmente ridefinita dal regista con una gamma di “colori” altrettanto corposi ed un pennello (la cinepresa) ugualmente creativo che – al di là delle apparenze di facciata - lascia trasparire tutta la mostruosità di quegli anni e delle figure (a tutti i livelli, anche quello artistico) che li popolavano.
Il risultato, è un’opera monumentale anche nelle dimensioni: 2 ore e 29 minuti di durata sapientemente utilizzate per raccontare quelle che (con un piccolo eufemismo) potremmo considerare come le due vite di Turner: da un lato quella privata appunto, che non riguarda solo i rapporti con suo padre, ma anche quelli con la sua domestica (e preda sessuale) afflitta da una psoriasi devastante, con la madre delle sue due figlie che ogni tanto lo viene a trovare per accusarlo della sua negligenza, o con la vedova di un capitano di navi negriere, che appare così bella ai sui occhi da potere essere paragonata alla dea Afrodite; dall’altro quella pubblica (istituzionale, si potrebbe dire) perfettamente inserita nelle regole imposte dalla società artistica del tempo prona al potere, con pittori di corte alla costante ricerca di adeguate protezioni e con i quali Turner intrattiene rapporti caustici e sussiegosi a base di pacche sulle spalle fra risatine, quale piccolo sfottò e sottese rivalità. Un’ufficialità ripresa con uno sguardo decisamente critico, ma necessaria per evidenziare quanto invece Turner poteva essere anche ribelle e focoso (alla sua maniera ovviamente), e soprattutto coraggioso, per esempio quando avrà l’ardire di ritoccare beffardamente un’opera di John Constable, uno dei suoi più temibili ed affermati concorrenti, o proverà a rimettere in riga il di lui più giovane John Ruskin, critico d’arte (ma anche scrittore, poeta e pittore) altrettanto famoso nel suo tempo.

Turner (2014): Timothy Spall

Turner (2014): scena
Della pittura di Turner, Leigh ci restituisce dunque e soprattutto, la dimensione materica, spogliata però da qualsiasi aura di maledettismo artistico, ce ne racconta l’istintività e la sofferenza, sempre presente e stratificata anche quando sembra che si stia parlando di altro, da far pulsare davvero ogni momento del film fino dai titoli di testa, mobili e liquidi come le onde dipinte dal pittore nel loro costante “movimento in divenire” capace di farci percepire persino i gorgoglii della risacca, quasi come se il regista avesse voluto fare dell’artista (azzardo un poco ma spero di essere compreso o perdonato per l’ardire) una specie di (inconsapevole) antesignano “cineasta” – il primo della storia – molti decenni prima che quella che sarà definita come “la settima arte” vedesse effettivamente la luce (non tanto per ciò che dipinge nei suoi quadri, ma proprio per l’atteggiamento che assume nei confronti dell’arte) e mi riferisco ovviamente più che alla verità storica, a quello che traspare – o è arrivato a me – dalla visione di questa pellicola.
Di quella dei fiamminghi (la sua ascendenza formativa che troverà il suo apice proprio in quel viaggio ad Anversa fatto per studiarla dal vivo e osservarne le profondità), il regista ci lascia invece traccia nella raffigurazione degli interni e nella loro costruzione analitica dentro l’inquadratura con le perfette geometrie delle forme e la simmetria dei totali che si ritrova anche nella studiata attenzione riservata ai dettagli: il riquadro di una porta, una scala ripresa dall’alto, la composizione degli oggetti sulla tavola.
Leigh segue il suo amato personaggio in molti luoghi e momenti e ce lo mostra da differenti angolazioni di visione anche contraddittorie (uno degli interrogativi a cui accennavo prima) persino per quel che riguarda la sua psicologia. Ecco allora che ci viene “raccontato” come un uomo non proprio edificante con molti “vizi” e pochissime virtù (capace comunque di impreviste, appassionate “dolcezze” come quando ascolta stupefatto e attonito, quasi estasiato, una pianista che suona la Patetica di Beethoven, e intona insieme a lei con commozione genuina e una voce incerta e dolente, un’aria di Purcell da Dido and Aeneas, o dichiara il suo amore - una volta tanto senza grugnire - con parole immaginifiche e barocche, degne di un poeta) ma al tempo stesso anche riflessivo e attento ai movimenti del pensiero e alle evidenti trasformazioni del progresso che già si intravedono all’orizzonte, come quando lo cogliamo a meditare intorno alla teoria dei colori o a valutare la portata degli esperimenti scientifici sulla luce. Su tutto però emerge soprattutto come un eccelso, inimitabile artista in anticipo sui tempi (anche per il suo particolare rapporto con la natura sempre diretto e mai mediato): un Turner che in tale veste e dimensione sembra quasi soffiare, rendendola vitale sulla tela, la composita, variegata e inedita tavolozza di colori da lui impastati con lo sputo, e usa i pennelli come se fossero mazzuoli che trafiggono le sue tele con vere e proprie sciabolate dalle sfumature più impensate, a volte tenuissime, altre più cupe ma mai accademiche, in forte anticipo sull’impressionismo (i famosi vascelli che dipinge, lui li va a riprendere “dal vivo” per percepirne tutte le vibrazioni, arrivando persino a farsi legare all’albero maestro di un veliero durante una burrasca marina solo per poterne cogliere le sfumature più nascoste e tempestose, e poterle poi riversare sulla tela facendole rivivere con attendibile aderenza – cromatica ed emozionale - come se fossero “registrate” in diretta (ma reinterpretate in forma al tempo stesso più drammatica e poetica), perché per lui la pittura è sempre stata “vita”, e soprattutto un battagliero corpo a corpo giornaliero finalizzato a introdurre nell’arte del pennello, nuovi protagonisti recuperati non solo dalle metodiche osservazioni del paesaggio, ma anche dalla “scoperta” di nuovi oggetti da immortalare, come il sincopato sbuffare della locomotiva di un treno in movimento, o il fedele ritratto di un rimorchiatore che – in un mare che trascolora e si dissolve nel cielo quasi senza soluzione di continuità – trascina alla demolizione il Fighting Temerarie, la storica nave che aveva combattuto e si era coperta di gloria, a Trafalgar, qui al suo ultimo, patetico viaggio.
Ce ne mostra infine le umane fragilità quando deve toccare con mano la scomoda evidenza che il rispetto e la stima possono sparire all’improvviso (è sufficiente a determinare “la caduta” un semplice, malevolo commento a corte) o si trova a esprimere il disorientamento e la paura rispetto al nuovo che avanza e che teme possa mettere in discussione anche il valore e l’importanza della sua pittura dentro a quel nuovo mondo in cui una macchina infernale chiamata dagherrotipo in pochi secondi produce delle fotografie impeccabili che potrebbero davvero rendere inutile persino la sua arte.

Turner (2014): Timothy Spall
Fragilità che riguardano però (e soprattutto) il suo rapporto con il “fine vita”: le sue reazioni dopo il decesso del padre, o quelle ancor più angoscianti del momento cruciale in cui reso scosso e atterrito dal dolore e dalla morte che non riesce a fissare sulla tela, si alza dal letto ormai quasi agonizzante, ed esce sulla strada dove è stato deposto il cadavere della giovane annegata (The Sun is God!!!).
Leigh insomma con questa stratificata opera, è davvero riuscito a mettere in quadro un pittore (ancora Bellavita) e la sua ossessione creativa, restituendo interamente allo spettatore la magia avvolgente delle sue tele grazie alle “mediazioni dinamiche” offerte dalla mobilità della cinepresa.
Un particolare plauso anche alla anticonformistica scelta della colonna sonora, fatta di una musica lontanissima dai consueti, scontatissimi (ed abusati) riferimenti settecenteschi, così antiaccademica e intrisa di pulsioni novecentesche, da risultare perfetta per proiettare nel futuro (o per meglio dire nella contemporaneità) la figura di un artista straordinario che con le sue innovazioni anche stilistiche, è andato ben oltre gli anni e il periodo della sua esistenza.
Un film insomma amorevole e girovago, dolente e focoso - come lo ha giustamente definito Bruno Fornara - da “gustare” soprattutto sul grande schermo della sala.
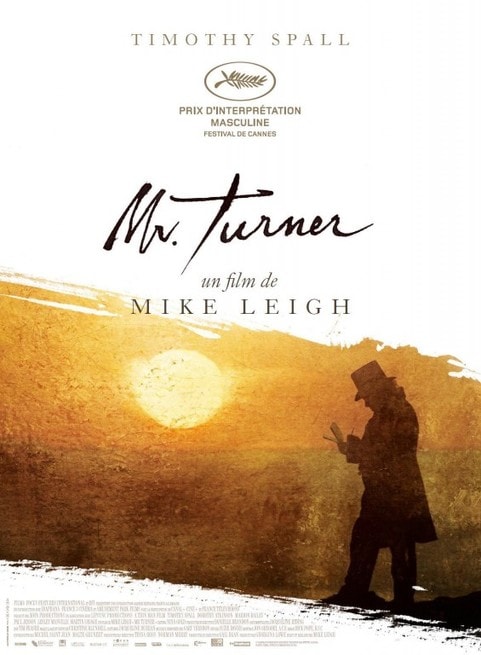
Turner (2014): locandina
Non ci sono commenti.
Ultimi commenti Segui questa conversazione
Recensione quasi poetica.
Mi resta di vedere il film, impresa molto ardua se si battono le sole vie legali.
Grazie @Jamix ti auguro di riuscire a vedeerlo (a Fiorenze è andato credo anche abbastanza bene come incassi, e può darsi che questo faciliti la distribuzione in altre zone che il numero limitato delle copie non aveva consentito di coprire.
Speriamo! Altrimenti dovrò andare in qualche cinema di Milano perché nei cinema di provincia neanche l'ombra!
Io sono dell'idea che questo film sia solamente un inno all'estetica fine a se stessa. Ho notato le splendide inquadrature l'ottima interpretazione di Timothy Spall e gli splendidi tramonti ma è quello che ci sta intorno che mi ha sconcertato. Non mi ha toccato affatto, l'ho trovato statico, noioso e privo di contenuto. Ottima recensione comunque, è un piacere seguirti :)
Ti ringrazio moltissimo per il commento e per l’apprezzamento. Rispetto ovviamente il tuo pensiero e ritengo altrettanto giusto che tu lo abbia espresso in maniera tanto netta.. Peccato davvero che tu non ci abbia trovato dentro quello che ci ho trovato io. Non sei comunque solo a pensarla in questo modo: la tua era infatti una posizione abbastanza condivisa anche da un gruppo di giovani (immagino studenti di qualche liceo o accademia artistica) che erano seduti proprio dietro a me durante la visione (IN LINGUA ORIGINALE) di un film che invece mi ha toccato davvero nel profondo e nel quale non ho riscontrato alcuno dei difetti che invece hanno disturbato la tua visione (ma il mio giudizio - come dico sempre - vale tanto quanto il tuo e sarà poi il tempo a rendere definitiva giustizia in un senso o nell'altro a questo “ritratto tutt’altro che accademico” - ancora un mio opinabilissimo di un grande pittore come Turner.
La tua recensione la trovo perfetta, estremamente puntuale e la condivido in pieno.
Ti ringrazio molto per questo.
A me sembra che, piano, piano, si stia affermando un concetto: il cinema può anche raccontare ciò che vede il protagonista del film non solo ciò che vive.
Secondo me lo è stato anche con "la ragazza dall'orecchino di perla" ma qui, mi sembra, si sia ancora di più approfondito il concetto.
Ovviamente la buona arte sfrutta appieno la "tecnologia" del suo tempo e, in questo caso, difficile sarebbe stato poter realizzare un film così, senza "l'alta definizione", ma proprio per questo vanno valutate con metri diversi, questo genere di opere cinematografiche.
Certo c'è una trama, ci sono analisi "letterarie" e "psicologiche" ma che bello poter immaginare di vedere ciò che vedeva un grande artista riproposto, non solo attraverso i suoi quadri ma anche attraverso i suoi occhi e l'ambiente in cui viveva; quest'ultimo "dipinto" con particolare, anche fastidioso, verismo: come sono brutti i volti delle persone e forti i colori della loro pelle strapazzata dalle intemperie e da un igiene approssimativa!
Spero davvero che prenda campo questo genere e che si continui a fare film così. Alla rappresentazione cinematografica si può chiede di esprimere la vita in modo diverso dal romanzo, dalla pittura, dal teatro e dalla musica: credo gli si possa domandare la magia della rappresentazione visiva, in cui l'occhio più di tutto, più degli altri sensi, si senta al centro della decifrazione espressiva.
In quanto al resto, alla magnifica interpretazione degli attori, alla costruzione narrativa, alla colonna sonora, ecc. niente da dire di più di ciò che hai così bene scritto e sulla cui analisi puntualissima, concordo appieno.
Grazie e speriamo si cominci a giudicare (anche) i film non solo con gli occhi del cinema visto ma anche di quelli con cui si vede.
Grazie per il tuo prezioso commento. Sono sostanzialmente d'accordo. Aggiungo solo che questo positivo risultato oltre alla tecnica e ai mezzi adesso disponibili grazie all'alta definizione, ha bisogno anche della forte (sapiente) mano di un regista che sappia controllare bene la materia, e che sia capace di guardare le cose (e riprodurle) con gli occhi dell protagonista della storia (che per delle opere che parlando di pittori) è proprio una delle compomenti principali di ciò che occorre per centrare perfettamete il bersaglio come è riuscito a fare Leigh in questa circostanza (ma anche Webber che citi pure tu, e Majewski con I colori della passione). Penso (almeno spero) che le stesse forti emozioni siano rintraccabili quando nel prossimo febbraio passerà in sala per soli due giorni credo, il documentario su Goya
Concordo e ammetto che non mi sono spiegato bene: volevo anche io dire che, il regista, per portare avanti il suo discorso ha avuto bisogno della tecnica la quale, senza competenza e senza "guida", è fine solo a se stessa.
I grandi Musical cinematografici, nati, ovviamente, dopo l'avvento del sonoro, sono Grandi perchè ci sono stati grandi registi e grandi interpreti che hanno saputo usare al meglio le nuove risorse tecniche, ecc., ecc. fino a dire che la scultura del marmo senza un martello non sarebbe potuta avvenire ma, ovviamente, il martello non fa sculture e non tutti quelli che usano il martello, per scolpire il marmo, sono grandi scultori.
Grazie per avermi permesso di esprimermi meglio e grazie per le tue preziose "note". Speriamo bene per Goya, hai ragione!
Commenta