Regia di Fruit Chan vedi scheda film
Far East Film Festival 19 – Udine.
«Il mondo cambia rapidamente, non fai tempo ad abituarti che già cambia di nuovo»
Presentato al festival di Locarno sotto l’egida di Marco Muller nel lontano 1997, Made in Hong Kong è scomparso dalla circolazione per troppo tempo - e per motivi francamente incomprensibili - salvato dall’oblio eterno dal Far East, alle prese con la produzione del suo primo restauro in 4K affidato a L’immagine ritrovata di Bologna, per un lavoro durato due anni coinvolgendo attivamente lo stesso Fruit Chan.
Ci sono opere, la maggioranza, da vedere una volta sola giusto per togliersi lo sfizio, alcune che vengono consacrate al primo colpo e infine ce ne sono altre che riemergono dall’oscurità e che meriterebbero di diventare classici immortali, disponibili a chiunque. Made in Hong Kong rientra a pieno titolo in quest’ultima categoria, la meno affollata delle tre.
Moon (Sam Lee) è un piccolo delinquente privato di ogni altra alternativa, che almeno cerca di tenersi lontano dai guai più grossi, occupando il suo inutile tempo con il disadattato, nonché ipersensibile al fascino femminile, Sylvester (Wenders Li).
Di punto in bianco, la sua scombussolata esistenza è scossa da due eventi: il suicidio di Susan (Amy Tam Ka-Chuen) sembra un crocevia del destino nonostante non l’abbia mai conosciuta, mentre l’incontro con Ping (Neiky Yim Hui-Chi), una ragazza minorenne malata terminale, lo porta a provare un nuovo stato emotivo: l’innamoramento.
Moon, Ping e Sylvester sono affiatati, ma tra i debiti della mamma della ragazza, che comportano le pressioni del temibile usuraio Fat Chan (Chan Tat-Yee), e i problemi mentali di Sylvester, Moon è costretto ad azioni preventive, noncurante delle possibili conseguenze, dato che l’unica cosa a importargli è il bene delle uniche due persone al mondo che gli sono vicine.
Made in Hong Kong (1997): locandina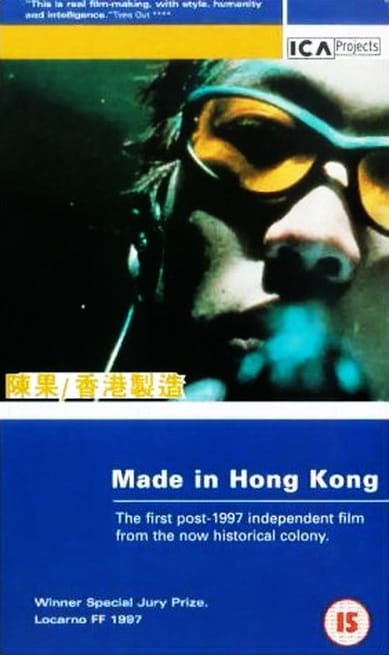
Made in Hong Kong è un distillato di grandissimo cinema, che sconvolge per i racconti umani descritti, coinvolge grazie a una freschezza che assume le forme di un poetico dono generazionale e infine abbraccia messaggi lampanti, facendo tombola nel momento in cui, oltre a calzare sulla realtà che disseziona, risulta pure dannatamente preveggente, dall’approdo universale e probabilmente destinato a essere entrambe le cose all’infinito, semplicemente vedendo un diverso recepimento in funzione delle diverse sensibilità.
Il primo miracolo è legato alla composizione del trio di belli, dannati e segnalati come difettosi: Moon nasce (e vuole vivere) libero, generalmente svuotato ma anche pronto a farsi in quattro per chiunque consideri di valore, Sylvester è tanto grande e grosso quanto indifeso e vessato, mentre Ping è conscia di avere una data di scadenza, di non poter già più correre come gli altri suoi coetanei e che ogni giorno vissuto equivale a uno guadagnato. Nonostante siano sommersi dai problemi, sono aggrappati a quel poco che la vita può loro regalare, l’alone di morte veglia sulle loro giornate ma poi bastano uno scherzo stupido, una battuta fuori posto o una passeggiata in un cimitero per incontrare una spensieratezza salvifica, un inno al recupero di quanto ritenuto marginale e che invece può (ancora e sempre) donare gioia a chiunque, senza esclusioni sociali. Il valore aggiunto a questa condizione discende dai legami che li uniscono, un amore e un’amicizia che fuoriescono agevolmente dagli schematismi che la vita stessa induce, assumendo sapori, colori e umori scomposti, irrazionali e non imbrigliabili, se non in una vena poetica e maledetta.
Con un dispositivo del genere. i tre protagonisti diventano soggetti attivi di un disegno universale, rappresentazione della disperazione di un’età attraversata da tumulti e dallo smarrimento, con il tocco cinefilo in più ritrovabile nell’utilizzo di poster cinematografici per contrappuntare caratteristiche fondamentali: nella stanza di Moon risalta quello di Natural born killers sottolineandole l’indole selvaggia ma non priva di amore, in quella di Ping c’è il manifesto di Belli e dannati, per ricordare la sua vita segnata di angelo senza futuro, mentre le azioni finali del protagonista sono anticipate dalla comparsa del poster di Leon. D’altro canto, a quel punto è arrivato il momento di sparare, una sequenza onirica di circa cinque minuti con un montaggio lussurioso che scavalca la mancanza di fondi sfogando una creatività illuminata, trasmettendo una serie trasbordante di suggestioni, partendo da una richiesta d’aiuto che per puro caso non può essere ascoltata, per poi scavallare ostacoli e passaggi distanti, per mezzo di iperboli trainanti.
Una pagina lacerante, vissuta da (giovani) angeli perduti - l’accostamento all’opera di Wong Kar-wai è assolutamente voluto - e demoni, ragazzi irrequieti e condannati senza appello, che subiscono per primi la destabilizzazione delle tensioni dovute ai cambiamenti mondiali, un collegamento diretto alla situazione di Hong Kong che, nel periodo in cui la pellicola è stata girata, stava vivendo l’handover, consistente nel trasferimento di sovranità alla Cina.
Un mare magnum che nasce dal talento creativo, indagatore, ascoltatore e infine critico di Fruit Chan, impegnato sia nella fremente sceneggiatura sia nell’articolata regia, generando un lunghissimo brivido che non vola via, trasmettendo quello spaventoso senso di inutilità che distrugge le persone psicologicamente, dando ai monologhi interiori di Moon un eco a cappello di tutto e impossibile da sottacere.
Come ognuno e ogni cosa ha la propria storia e la sua collocazione nel mondo, così Made in Hong Kong assume le sembianze di un capolavoro epocale - di ieri, finalmente candidato a esserlo anche oggi e destinato a risplendere per sempre, nella notte dei tempi - e generazionale, per nulla confinato ma rivolto a tutti i passaggi generazionali che continuano ciclicamente, toccando direttamente ciascuno di noi.
Senza bandiere, perché siamo tutti esseri umani e il grande cinema appartiene a tutti.
Non ci sono commenti.
Ultimi commenti Segui questa conversazione
Commenta